Questo saggio viene presentato in due parti; la prima qui di seguito, mentre la seconda parte sarà pubblicata sul prossimo numero di Proteo
Introduzione
Il paradigma dei diritti di proprietà, elaborato dai classici e da Marx per definire il capitalismo, domina ancora oggi il pensiero economico, non solo quello marxista, ma anche gran parte di quello neoclassico e istituzionalista. Secondo questo paradigma il capitalismo è un sistema economico in cui il controllo della produzione e dell’allocazione delle risorse sono assicurati dalla proprietà privata dei mezzi di produzione. È una concezione che si è andata formando sulla base dell’osservazione del sistema economico inglese del primo ’800 e sembra strano che prevalga tuttora, nonostante il pionieristico lavoro di Berle e Means (1939) e il filone di ricerca da esso aperto. Sembra particolarmente strano che predomini anche nel pensiero marxista, visto che Marx è stato il primo economista ad aver teorizzato in modo rigoroso la tendenza alla crescente separazione tra proprietà e controllo (1964, III, capp. 23, 27). Eppure fenomeni come l’affermazione della public company, il capitalismo di stato, il capitalismo finanziario, la rivoluzione manageriale, la rivoluzione dei fondi pensione sono sotto gli occhi di tutti. E sebbene la proprietà privata dei mezzi di produzione sia sempre più diffusa nel capitalismo contemporaneo, esistono tuttavia diversi assetti istituzionali che sembrano aver tolto alla proprietà gran parte del suo potere di controllo nel processo produttivo, nell’allocazione delle risorse e nel governo dell’accumulazione.
La ricerca recente ha portato a chiarificare la natura del diritto di proprietà, ad esempio mostrando che esso può essere ridotto all’unione di due diversi diritti, quello al reddito residuale e quello al controllo residuale (Grossman e Hart, 1986; Hart e Moore, 1990). Il primo consiste nel diritto a percepire i redditi prodotti dall’uso dei mezzi di produzione in eccesso rispetto ai redditi fissati contrattualmente; il secondo consiste nel diritto a controllare i mezzi di produzione per gli usi che travalicano gli obblighi stabiliti contrattualmente. La tesi prevalente è che il diritto residuale di controllo assicuri il rapporto d’autorità che consente di piegare l’attività lavorativa alla produzione del profitto residuale. E tuttavia vari tipi di processi economici si sono affermati nel capitalismo contemporaneo - come la crescita delle mega-imprese globalizzate e la diffusione di investitori istituzionali che raccolgono il risparmio tra vasti strati della popolazione, anche operaia - che hanno contribuito a spingere a livelli mai visti prima il fenomeno della separazione tra proprietà e controllo, ovvero tra diritti al reddito residuale a diritti al controllo residuale.
L’osservazione di questi fenomeni pone al ricercatore due ordini di problemi teorici di grande rilevanza. Il primo riguarda la necessità di una definizione generale di capitalismo. È possibile inquadrare le diverse forme istituzionali di capitalismo affermatesi nella storia in un unico tipo ideale chiamato modo di produzione capitalistico? E se sì, qual è l’istituzione fondamentale del capitalismo, quella che è comune a tutte le forme istituzionali? Il secondo riguarda la definizione delle forme stesse. Come possono esser distinte le une dalle altre? Ed è possibile classificarle entro uno schema semplice e significativo che consenta di metterne in luce sia le differenze che somiglianze? [1]
Nella prima parte di questo saggio si tenterà una soluzione al primo problema, avanzando la tesi che l’istituzione fondamentale del capitalismo è il contratto di lavoro [2] e non la proprietà privata dei mezzi di produzione. La questione cruciale è che l’estrazione di un reddito residuale dall’uso dei mezzi di produzione presuppone il controllo del processo produttivo, ma la detenzione del controllo residuale dei mezzi di produzione non garantisce il controllo degli agenti economici che li usano. E le macchine da sole non producono niente. I lavoratori non possono essere diretti, comandati e sfruttati se non hanno assunto nei confronti del datore di lavoro un obbligo all’obbedienza. Questo obbligo però non è generato dai diritti di proprietà, bensì dal contratto di lavoro. Ne consegue che il controllo residuale sul processo produttivo può essere esercitato anche da soggetti economici che non detengono alcun diritto di proprietà sui mezzi di produzione, ma che tuttavia sono in grado di assicurare che il processo produttivo venga piegato alla produzione di un sovrappiù e che questo venga usato per sostenere l’accumulazione del capitale. Il che implica la seguente definizione provvisoria di capitalismo: un modo di produzione in cui si estrae plusvalore dall’uso del lavoro salariato e si impiega il plusvalore per alimentare l’accumulazione del capitale.
Nella seconda parte del saggio si affronterà l’altro problema, proponendo uno schema di classificazione delle diverse forme di capitalismo. Verranno introdotti i concetti di “regimi di proprietà” e di “strutture di governo dell’accumulazione”, e verrà mostrato che la funzione svolta dai primi nella distribuzione del plusvalore è separabile da quella svolta dalle seconde nella disciplina dell’attività d’investimento. La classificazione emergerà dall’individuazione dei modi in cui diversi tipi di regimi di proprietà possono combinarsi con diversi tipi di strutture di governo.
I. IL CONTRATTO DI LAVORO. Alcuni tipi di contratto che possono essere usati per mobilitare il lavoro
Si consideri un soggetto economico, B, che decide di intraprendere un’attività volta alla produzione di profitti e di coinvolgere a tal fine dei lavoratori, L. Si faranno per ora le seguenti ipotesi sullo stato del mondo. Tutti gli individui sono auto-interessati ma leali, e nessuno nasconde informazioni. Non è difficile raccogliere le informazioni rilevanti per effettuare i calcoli di convenienza e i calcoli stessi non sono troppo complicati. Tutti gli individui hanno lo stesso grado di avversione al rischio. Tutti gli accordi sono semplici e immediati. Non esistono costi di transazione. I mezzi di produzione e le abilità dei lavoratori non sono vincolati a una particolare produzione e in ogni momento possono essere disinvestiti senza perdita di valore, a parte il normale deprezzamento. Infine è in vigore il “principio di equivalenza”, un criterio di valutazione negli scambi in virtù del quale il prezzo di ogni merce coincide col valore attuale dei suoi rendimenti attesi e col costo sostenuto per produrla. Il problema è: che tipo di accordo proporre ai lavoratori per indurli a produrre profitti?
Prima di rispondere a questa domanda è necessario osservare che le ipotesi fatte non hanno alcun intento descrittivo. Servono a sostenere un ragionamento controfattuale. Sono state tolte tutte le condizioni che nella corrente letteratura neoistituzionalista vengono addotte a giustificazione del contratto di lavoro: razionalità limitata, incompletezza e asimmetria informativa, opportunismo, differenziazione sociale dell’avversione al rischio, costi di controllo, costi di transazione, specificità degli investimenti. Si vuole mostrare che anche in questo strano mondo c’è motivo per fare ricorso al contratto di lavoro, che nessuna di quelle condizioni particolari è necessaria per l’esistenza di tale tipo di contratto. Si spera così di portare alla luce la ratio del contratto di lavoro. Anche a tal fine è stato assunto un principio di equivalenza che nessuno ha mai visto in funzione nel mondo capitalistico, benché sia in funzione in gran parte della teoria economica moderna [3] essendo implicito nell’ipotesi di concorrenza perfetta. È proprio a tale livello di astrazione che si riesce a afferrare la vera natura del contratto di lavoro.
La quale si comprende bene facendo un confronto con altri tipi di transazione che possono essere usati per mobilitare il lavoro. Ne vengono considerati quattro: di società, di mandato, d’opera, di mezzadria. [4] I due soggetti, B e L, stipulano un contratto al tempo to in vista dello svolgimento di un’attività produttiva che verrà completata al tempo t1. A L verrà pagato un reddito, w, la cui entità potrà essere definita al tempo to o al tempo t1. In cambio L svolgerà un’attività lavorativa, x, nel periodo del processo lavorativo, t1-to. I vari tipi di contratto si differenziano per diverse caratteristiche, e in particolare per l’oggetto scambiato, per il tempo in cui viene deciso w, per il tempo in cui viene decisa x, per il soggetto che decide x. Nella tabella 1 vengono mostrate schematicamente le caratteristiche principali dei cinque tipi di contratto.
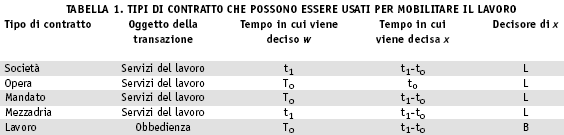
Nel contratto di società due o più soggetti conferiscono beni o servizi per l’esercizio di un’attività economica in comune allo scopo di ripartirne i profitti. Esistono diversi tipi di società, ma qui, per lasciare il discorso più semplice possibile, si ipotizzerà che il capitale o è conferito da tutti i soci in parti uguali o è preso a prestito dalla società. In ogni caso si assume che tutti i soci conferiscano servizi del lavoro di uguale valore, cosicché gli utili, al netto degli interessi sul capitale, [5] verranno ripartiti in parti uguali. Non c’è nessuna differenza tra B e L. L’oggetto della transazione in questo tipo di contratto è l’insieme dei servizi del lavoro che i soci apporteranno nel processo produttivo. La misura del contributo lavorativo dei vari soci viene stabilita al momento della stipula del contratto, però gli specifici servizi prestati verranno decisi nel corso del ciclo produttivo, cioè nel periodo t1-to. Il potere decisionale spetta a tutti i soci e comunque, anche se uno di essi viene eletto direttore, la sua facoltà decisionale proviene dalla volontà dei soci. Infine il tempo in cui vengono decise le remunerazioni è t1, cioè il momento della chiusura del processo produttivo e della divisione degli utili. Questo tipo di contratto non può generare sovrappiù per nessuno se le quote dei redditi, al netto dell’interesse, coincidono con il valore dei servizi lavorativi. Ciò che accadrà se il valore aggiunto coincide con la somma degli interessi e del valore dei servizi apportati dai lavoratori.
Col contratto d’opera il soggetto L si impegna a compiere un servizio o un insieme di servizi per B senza vincolo di subordinazione. Si obbliga a fornire una specifica opera e non a prestare genericamente energia lavorativa. Il soggetto B, in questo caso, chiederà a ogni lavoratore di vendergli precisamente le prestazioni desiderate. I lavoratori accetteranno volentieri se i servizi del loro lavoro verranno remunerati equamente. La remunerazione viene stabilita al momento della stipulazione del contratto, to. Anche la natura dei servizi è definita al tempo to. Il modo in cui i servizi vengono prodotti, però, sarà un problema di L. Ciò che conta è che al termine stabilito questi sia in grado di consegnare il risultato della sua attività come concordato. Anche in questa caso accade che nessuno dei due soggetti potrà guadagnare un profitto. Per la precisione ciò accadrà se il valore del servizio prodotto è uguale al reddito pagato da B a L e quest’ultimo è uguale al costo sostenuto da L per produrlo.
Nel contratto di mandato il mandatario, L, si impegna a compiere degli atti per conto e nell’interesse del mandante, B. Il mandatario mantiene una completa autonomia decisionale. In questo caso i lavoratori lavoreranno autonomamente nell’impresa del signor B, prenderanno liberamente tutte le decisioni produttive. Ma lo faranno nell’interesse di lui. Questi, conoscendone la lealtà, non ha alcun dubbio sulla loro volontà di erogare lo sforzo e l’intelligenza necessari per raggiungere gli scopi loro preposti. I servizi lavorativi vengono decisi da loro nel corso del processo produttivo. I lavoratori saranno pagati equamente e i loro redditi saranno proporzionali al valore dei servizi erogati. Il loro compenso può essere definito al momento della stipulazione del contratto [6] e, vigendo il principio di equivalenza, coinciderà col valore dei servizi. I redditi residuali spettano a B, ma coincideranno con gli interessi sul capitale.-----
Il contratto di mezzadria istituisce una forma di associazione tra il concedente, B, e il mezzadro, L, in forza della quale quest’ultimo fornisce l’attività lavorativa necessaria per lo svolgimento di un processo produttivo i cui mezzi di produzione appartengono a B. Sebbene i fini della produzione possano essere decisi da B, con o senza la partecipazione decisionale di L, i servizi lavorativi, x, vengono apportati da L e decisi da lui, in piena autonomia, nel periodo t1-to. I profitti vengono ripartiti generalmente in parti uguali tra B e L. Sembra possibile che con questo accordo si possa guadagnare un profitto netto, ciò che accadrà se la quota di reddito di B è superiore agli interessi sul capitale. Ma proprio per questa ragione l’accordo sarà percepito come iniquo dai lavoratori. Essi hanno erogato un’attività produttiva e decisionale producendo un valore, solo una parte del quale gli torna come remunerazione. Perciò, se deve essere applicato il principio di equivalenza, bisognerà che il valore dei servizi resi dal mezzadro sia precisamente uguale al 50% del valore aggiunto. Nel qual caso neanche questo tipo di contratto consentirà a B di incamerare un profitto. Ad ogni modo non è necessario che la divisione dei profitti venga fatta al 50% e in generale lo schema di mezzadria può essere preso a prototipo di una vasta serie di schemi di pagamento nei quali la retribuzione di L viene fatta dipendere dal risultato produttivo. Si pensi ai pagamenti in base alla performance, ai cottimi a pezzo e a risultato, alle provvigioni, ai bonus di gruppo, ai premi d’operosità, alla partecipazione agli utili ecc. In tutti questi casi però vale lo stesso risultato che si è ottenuto con la mezzadria in senso stretto: se la remunerazione di L coincide con la sua produttività, B non è in grado di estrarre un profitto dall’uso del lavoro.
Il contratto di lavoro e l’impresa capitalistica
C’è infine una quinta possibilità: proporre ai lavoratori un accordo in virtù del quale essi accettano di rinunciare alla propria autonomia decisionale per un certo numero di ore al giorno, durante le quali svolgeranno attività lavorativa sotto il comando del signor B. In base a questo accordo i lavoratori non conoscono ex ante che tipo di attività saranno chiamati a svolgere. Né gli interessa saperlo. La loro attività durante l’orario lavorativo non sarà più una loro azione, ma sarà una manifestazione della volontà del datore di lavoro e un mezzo per la realizzazione dei suoi fini. Qualunque remunerazione essi riceveranno, non ci sarà alcun modo di ricondurla ai servizi lavorativi da essi erogati, poiché tali servizi si configurano in realtà come appartenenti al signor B. Che cosa questi farà con le ore del loro tempo lavorativo è un suo problema e una sua prerogativa. Così la loro remunerazione non si configura come il prezzo di una merce e il valore del prodotto ottenuto con la loro attività non si configura come valore prodotto da loro. Il salario non è il prezzo dei servizi lavorativi, ma un compenso per l’impegno all’obbedienza. Non c’è quindi motivo di fare appello al principio di equivalenza nel fissare il salario, il quale infatti è determinato ex ante indipendentemente dalla produttività del lavoro; anzi, non c’è proprio modo di farlo. Perciò è possibile che il signor B riesca a ottenere con l’attività lavorativa a sua disposizione un valore aggiunto che, al netto degli interessi, risulta superiore a quello pagato ai lavoratori in cambio della loro obbedienza, cioè un profitto.
Se w viene deciso alla stipulazione del contratto, x viene invece deciso durante il processo produttivo, e viene deciso da B. È importante capire che il contratto di lavoro si distingue da tutti gli altri tipi di transazione finora esaminati per il fatto che in esso non si scambia una merce. Quegli altri tipi in effetti consistono in accordi che regolano lo scambio di una merce, i servizi del lavoro. Perfino il contratto di società, nella misura in cui i soci conferiscono lavoro, può configurarsi come una forma di scambio, per la precisione come uno scambio multilaterale. E in tutti i casi il reddito percepito dai lavoratori rappresenta una remunerazione del contributo produttivo arrecato dal bene che essi apportano. Non così col contratto di lavoro, nel quale al momento della stipula il lavoratore non è tenuto a sapere niente delle specifiche attività che verrà chiamato a svolgere. Qui non si scambia un bene, si assume un obbligo all’obbedienza. Con quest’obbligo il lavoratore rinuncia alla propria autonomia decisionale per un certo numero di ore al giorno e il datore di lavoro acquisisce potere di comando sul lavoro. L’attività lavorativa, dopo la stipula del contratto, non si presenta come un’azione del lavoratore, bensì come un’azione del datore di lavoro. E il prodotto che si ottiene tramite essa appartiene al datore di lavoro, cosicché non c’è ragione per collegare la remunerazione del lavoratore a un suo contributo produttivo. Ovviamente esiste pur sempre un contributo produttivo dell’attività lavorativa, ma non è, legalmente, un contributo del lavoratore. Inoltre, proprio poiché col contratto di lavoro non si scambia un bene, la remunerazione del lavoratore non si configura come il prezzo di una merce.
È precisamente per questa ragione - perché il salario non è il prezzo dei servizi del lavoro - che il datore di lavoro può riuscire ad estrarre un profitto dall’uso del lavoro. Infatti, poiché il contributo produttivo dell’attività lavorativa non è pertinenza del lavoratore, non c’è modo di ricondurre il salario al valore del rendimento del lavoro; mentre, poiché il salario non è il prezzo di una merce, non c’è modo di ricondurlo a un costo di produzione. In altri termini, non si può invocare il principio di equivalenza per la determinazione del salario. E coloro che volessero giustificare quel principio con un’ipotesi di concorrenza perfetta dovrebbero riflettere sul fatto che mai, neanche ai primordi del capitalismo, come già Adam Smith mostra di aver capito perfettamente, il salario è stato determinato propriamente sulla base della legge della domanda e dell’offerta.
L’obbligo all’obbedienza assunto dal lavoratore col contratto di lavoro istituisce l’impresa capitalistica, la quale può essere definita come un’organizzazione basata su una gerarchia di potere finalizzata alla produzione di profitti. L’impresa capitalistica è un nesso di contratti di lavoro, vale a dire proprio l’opposto di ciò a cui pensano i teorici del “nesso di contratti”. Per conoscerne le ragioni d’esistenza non c’è bisogno di sapere nulla del funzionamento del mercato, tanto meno delle sue imperfezioni. Essa non nasce in effetti da nessuna imperfezione del processo di scambio mercantile. Né i costi di transazione, né l’incertezza, né le asimmetrie informative, né alcun altro tipo di fallimento del mercato generano le condizioni d’esistenza dell’impresa capitalistica. Le teorie che sostengono il contrario si basano in realtà su una qualche confusione riguardo alle forme contrattuali che possono essere usate per la mobilitazione del lavoro.
Per afferrare la ratio dell’impresa capitalistica, ad esempio, bisogna evitare di confondere il contratto di lavoro con quello di mandato. [7] In quest’ultimo infatti il mandatario conserva la propria autonomia decisionale nel processo produttivo, il contratto impegnandolo solo a impiegarla per i fini posti dal mandante. Nel contratto di mandato vengono scambiati dei servizi lavorativi, insieme alla delega ad una delle parti di definirne autonomamente la natura nel corso del processo produttivo. Si tratta di un accordo perfettamente definito nella sfera del mercato, il quale dunque non fa difetto come meccanismo di allocazione dei servizi lavorativi. Ma se l’accordo funziona, in una situazione in cui il mandatario è neutrale al rischio come il mandante, non c’è modo per quest’ultimo di usarlo per estrarre profitti dal processo produttivo.
Bisogna evitare anche di confondere il contratto di lavoro con quello d’opera. E la tendenza di molti economisti contemporanei a considerare il primo come un contratto incompleto deriva proprio dall’incapacità di distinguerlo dal secondo. [8] Il contratto di lavoro non presuppone la conoscenza ex ante della natura del processo lavorativo, poiché i compiti dei lavoratori e i servizi lavorativi potranno essere definiti dopo la stipula del contratto. Invece nel contratto d’opera, dovendosi scambiare degli specifici servizi del lavoro, è necessario che la natura del processo lavorativo sia nota ex ante. Quando chiamiamo l’idraulico a ripararci il lavandino sappiamo qual è il tipo di servizio che chiediamo e, se l’idraulico conosce il valore del proprio capitale ed è in grado di farselo pagare, non c’è modo di estrarre un profitto usando questo tipo di transazione.
Il contratto di lavoro è un’altra cosa, e non deve essere considerato come una forma incompleta di quello di mandato o di quello d’opera. E poiché non si configura come un contratto di scambio di una merce, in esso l’allocazione del lavoro non è assicurata dal mercato. In effetti è definita nel processo lavorativo e all’interno di una struttura gerarchizzata: l’impresa capitalistica. L’origine di tale struttura non dipende da un fallimento del mercato ma solo da una cosa: l’aspirazione al profitto del datore di lavoro.
Si osservi che questa teoria dell’organizzazione non è una teoria dell’impresa generica; è una teoria dell’impresa capitalistica. Il carattere capitalistico dell’impresa è essenziale per capirne la natura e la ratio. Ed è proprio tale carattere che consente di cogliere l’essenzialità della gerarchizzazione dei rapporti sociali al suo interno. Si tratta solo di una gerarchia elementare, a questo livello d’astrazione. È una gerarchia che non ha finalità di controllo, se non esistono asimmetrie informative. Né ha finalità di coordinamento, se non esistono neanche rendimenti di scala crescenti o produzione di squadra. Altrove (Screpanti, 2001) si è mostrato che man mano che ci si avvicina alla realtà, nella definizione del comportamento degli agenti economici e delle condizioni di produzione, la gerarchia di fabbrica si arricchisce di funzioni e di complessità. Ma è solo al presente livello di astrazione che si riesce a cogliere il fondamento istituzionale di ogni tipo e di ogni funzione della gerarchia capitalistica. Resta sempre vero infatti che la legittimità del comando capitalistico, qualunque sia la sua funzione particolare, deriva dall’impegno dal lavoratore all’obbedienza. In altri termini, quella istituita dal contratto di lavoro è una gerarchia di potere e, in quanto tale, è fondamentale.
Ciò che si è voluto dimostrare è che il contratto di lavoro è la forma di transazione con cui si costituisce l’organizzazione economica che usa il capitale nel processo produttivo al fine di estrarre un plusvalore. Questa forma contrattuale infatti, generando il comando sul lavoro, pone le condizioni per il controllo del processo lavorativo da parte del capitalista. I rapporti di forza tra le classi poi determineranno il salario, mentre l’abilità manageriale del datore di lavoro determinerà la produttività del lavoro. Dall’interazione di questi due fattori dipenderà la grandezza dello sfruttamento. Con gli altri tipi di contratto invece lo sfruttamento presuppone la trasgressione del principio di equivalenza e dipende unicamente dalla forza espressa dalle parti nel processo di contrattazione delle remunerazioni, e comunque non dal controllo capitalistico del processo lavorativo. Quindi la prima differenza fondamentale tra il contratto di lavoro e gli altri tipi di transazione considerati ha a che fare con l’assegnazione del controllo produttivo ai capitalisti invece che ai lavoratori.
Ma c’è una seconda differenza fondamentale. Si deve infatti osservare che, se il funzionamento dei mercati garantisse l’equivalenza degli scambi, non si potrebbe ottenere sfruttamento dall’uso delle forme contrattuali in cui vengono scambiati i servizi del lavoro. Tuttavia l’applicazione del principio di equivalenza alla remunerazione dei servizi lavorativi, nel caso del contratto di lavoro, è compatibile con lo sfruttamento in quanto questo tipo di contratto fa sì che l’erogazione dei servizi del lavoro sia opera dei capitalisti invece che dei lavoratori. Così, mentre lo sfruttamento eventualmente generato dagli altri tipi di contratto può essere interpretato come la conseguenza della trasgressione di un elementare principio etico degli scambi, ciò non è più possibile con il contratto di lavoro.-----
Dunque questa è l’istituzione fondamentale del capitalismo in generale. E deve essere presente in tutte le forme particolari di capitalismo. È una condizione necessaria per l’estrazione di plusvalore nel processo produttivo. A tale proposito tre questioni vanno messe in chiaro.
Innanzitutto, la condizione è necessaria per l’estrazione del plusvalore nel processo produttivo, non per lo sfruttamento tout court. Anche i rapporti di scambio di mercato, come si è visto, possono essere usati per sfruttare. In tutti i casi in cui si dà scambio ineguale c’è sfruttamento di mercato. Ma questa non è una forma di sfruttamento tipica del capitalismo, sebbene sia ampiamente diffusa in tutti tipi di capitalismo verificatisi storicamente. Può darsi, infatti, anche in un sistema di socialismo di mercato, quando ad esempio una cooperativa operaia ne domina un’altra con cui ha un contratto d’appalto.
In secondo luogo, non è una condizione sufficiente per lo sfruttamento nel processo produttivo. Infatti può accadere che, in presenza di particolari rapporti di forza tra le classi, i lavoratori riescano ad attivare forme di contropotere in fabbrica che annullino il profitto d’impresa. Oppure che i manager e i quadri siano così inefficienti che la produttività del lavoro non riesca a superare il salario.
In terzo luogo, non è una condizione sufficiente perché lo sfruttamento sia di tipo capitalistico. Se il sovrappiù non è usato per sostenere l’accumulazione del capitale, non si può più parlare di capitalismo. Per prendere di nuovo l’esempio di un sistema socialista, è possibile che una cooperativa assuma dei lavoratori salariati e li sfrutti estraendo dal loro lavoro un sovrappiù che verrà consumato dai soci cooperatori.
Cosa si vende quando si vende “lavoro”?
Potrebbe sembrare una domanda banale. E gli si darà una risposta banale se si accetta il luogo comune secondo cui il lavoro o la “forza-lavoro” è una merce: si vende appunto una merce. Eppure resta il dubbio - per dirlo con Karl Polanyi (1944) - che la descrizione del lavoro come merce è un travisamento della realtà e che il mercato del lavoro è un sistema di rozze finzioni. D’altra parte ci si potrebbe domandare: quale merce ci vende l’idraulico a cui chiediamo di ripararci il tubo del lavandino? Ed è possibile che sia la stessa cosa che lui ha acquistato dal suo lavorante quando lo ha assunto con un contratto che lo impegna a eseguire le operazioni che lui gli ordinerà di compiere durante l’orario lavorativo? E mettiamo che la nostra riparazione sia stata effettuata fisicamente dal lavorante, sotto la direzione del suo datore di lavoro. Qual è il lavoro che paghiamo: quello dell’idraulico o quello del lavorante?
Le difficoltà nascono forse dal fatto che il termine “lavoro” è suscettibile di diversi usi. Spesso con esso ci si riferisce a una serie di operazioni di trasformazione di oggetti, vale a dire a ciò che più propriamente si chiama “attività lavorativa”. Evidentemente l’attività lavorativa non è una merce. All’idraulico non chiediamo di venderci operazioni consistenti nello svitare delle ghiere, togliere un tubo, tagliare un altro tubo, montarlo sotto il lavandino ecc. Gli chiediamo semplicemente la riparazione del tubo. Gli chiediamo cioè di venderci un servizio. Per procurarci questo servizio l’idraulico dovrà compiere delle azioni, dovrà cioè prendere delle decisioni concernenti una particolare attività lavorativa, eseguire o far eseguire da altri quelle decisioni e produrre degli effetti di trasformazione di oggetti che siano conformi a uno scopo, nella fattispecie la predisposizione di un tubo funzionante. L’“azione lavorativa” è un insieme di decisioni relative a un’attività lavorativa che producono degli effetti conformi a uno scopo. L’azione lavorativa è una cosa diversa dall’attività lavorativa: primo, perché implica delle decisioni; secondo perché comporta degli effetti conformi a uno scopo. Ma neanche essa è una merce. Dall’idraulico non compriamo le sue decisioni o la sua facoltà decisionale. Compriamo solo i servizi procurati da un’azione, cioè gli effetti di decisioni. Questi sono i “servizi lavorativi”.
Si è ora in grado di dare una prima risposta a quella domanda. Quando si compra “lavoro” con un contratto d’opera si comprano in realtà i servizi del lavoro, cioè gli effetti di particolari azioni lavorative. Ciò che si paga in cambio è il valore dei servizi del lavoro. E l’attore che ha titolo al pagamento è il decisore dell’azione che ha prodotto i servizi, non l’esecutore delle sue decisioni. Quando paghiamo l’idraulico noi paghiamo proprio l’idraulico, cioè i suoi servizi, indipendentemente dal fatto che le sue decisioni siano state eseguite da lui o da un suo dipendente. In questo tipo di contratto il principio di equivalenza è rispettato se il valore del servizio venduto coincide col costo dell’azione compiuta per produrlo. Tale costo può includere, oltre a quello delle materie prime e dei mezzi di produzione usati nell’azione, il salario pagato al dipendente e il valore del rendimento del “capitale umano” dell’idraulico. In entrambi i casi non c’è sfruttamento del venditore se il principio di equivalenza viene rispettato: l’idraulico non è sfruttato dall’utente o viceversa.
Ma cosa dire del suo dipendente? Cosa vende lui al suo datore di lavoro? Col contratto di lavoro non vengono vendute né attività lavorative né azioni lavorative né servizi del lavoro; non viene venduto lavoro in nessun senso. Non l’attività lavorativa, perché, sebbene il lavoratore sarà tenuto a compiere delle attività, il contratto non specifica le operazioni che dovrà svolgere; infatti il lavoratore può essere impiegato in molte diverse mansioni, in molte diverse operazioni e, in presenza di un’innovazione, perfino in attività che non potevano essere note al momento della stipula del contratto. Non azioni lavorative, perché il lavoratore dipendente è pagato per eseguire decisioni altrui, cioè non per prendere decisioni, non per compiere azioni lavorative. Non servizi del lavoro, infine, perché questi sono i risultati di azioni lavorative e quindi sono prodotti dai decisori delle azioni.
Il contratto di lavoro in realtà istituisce la facoltà del datore di lavoro di decidere in merito all’attività lavorativa. E la istituisce obbligando il lavoratore a svolgere delle operazioni sotto il comando di quello. Esso genera la capacità del datore di lavoro di compiere azioni lavorative pur senza svolgere attività lavorativa, ma semplicemente dirigendo l’attività dei lavoratori.
Dunque il lavoratore salariato non vende una merce. È per questo che il salario che riceve non si configura come il prezzo di una merce. Non è il prezzo delle attività lavorative svolte, perché queste possono essere molteplici, eterogenee, variabili e anche ignote al momento in cui viene stabilito il salario; il quale, poi, non varierà al variare delle operazioni svolte dal lavoratore. Né è il prezzo delle azioni lavorative, poiché queste sono compiute dal datore di lavoro e non dal lavoratore. Non è infine il prezzo dei servizi del lavoro, poiché questi, in quanto effetti conformi a uno scopo, sono prodotti dall’azione lavorativa, e quindi appartengono al datore di lavoro, non al lavoratore. Come già osservato, il salario si configura come un premio per l’obbedienza; e l’obbedienza non è una merce.
Non si può dire comunque che il principio di equivalenza sia trasgredito nella fissazione del salario. Il punto è che esso non è applicabile; e per il semplice motivo che non è in gioco la determinazione del valore di una merce. Tuttavia quel principio resta in vigore nella determinazione del valore dei prodotti del “lavoro”; il quale infatti dovrà coincidere col valore dei servizi lavorativi. E siccome tali servizi sono prodotti dall’azione lavorativa, la loro remunerazione pertiene al datore di lavoro. Se questi è in grado di prendere decisioni che esaltano la produttività del lavoro, il valore così generato appartiene a lui. Il lavoratore non ha titolo ad appropriarsi i frutti della propria attività, poiché questa produce valore solo nella misura in cui si trasforma in azione lavorativa, ma in quanto tale non è più di pertinenza del lavoratore.
Ad ogni modo, il fatto che il principio di equivalenza venga rispettato nella determinazione del valore dei servizi del lavoro non significa che non esiste sfruttamento del lavoratore salariato. Significa però che questo tipo di sfruttamento può esistere solo in quanto il salario non è commisurato agli effetti ottenuti per mezzo dell’attività lavorativa. Né il fatto che il plusvalore prodotto nell’impresa capitalistica sia legittimamente appropriato dal capitalista significa che il lavoratore non è sfruttato. Lo sfruttamento capitalistico non ha niente a che vedere con la legittimità dei diritti di proprietà che possono essere vantati sulle merci, come aveva ben capito Marx. Esso può invece esistere perché il contratto di lavoro sottrae la remunerazione del lavoratore al principio di equivalenza; perché il salario viene fissato indipendentemente dal valore dei servizi del lavoro, questi ultimi venendo attribuiti all’azione del datore di lavoro.
Per capire la natura del rapporto sociale istituito col contratto di lavoro può forse essere utile risalire alle sue origini, quella locatio operarum la cui esistenza è accertata già dalla fine del I secolo a. C. La concretezza e il materialismo della filosofia giuridica romana ci consegnano dei concetti di istituzioni negoziali che sono abbastanza esenti dalle incrostazioni ideologiche apportate dalla mentalità moderna, e ciò può aiutarci a capirne l’essenza. Il problema di cosa si vende quando si vende lavoro si presenta nel diritto romano nei termini della definizione della natura dell’obbligazione assunta dal locator operarum: è un’obbligazione a dare o a facere?
Locare significa “collocare”, “porre”, “mettere a disposizione”, e generalmente si riferisce all’obbligo di consegnare una cosa al conductor, che da parte sua si obbliga a restituirla e a pagare una merces, una remunerazione, per il suo uso. La figura più consueta è dunque quella della locatio rei, la locazione di una cosa, un terreno, un’abitazione, un mezzo di produzione ecc., nella quale il locatore assume l’obbligo di dare. Diversa è la locatio operis, il contratto d’opera, in cui viene ceduto uno specifico servizio lavorativo, e in cui il lavoratore assume l’obbligo a facere delle specifiche azioni lavorative. La locatio operarum però, la locazione di lavoro in generale, ovvero della capacità generica di compiere opere, è un’altra cosa, in quanto in essa non vengono stabilite ex ante le opere specifiche che devono essere eseguite.
Secondo un’interpretazione che sembra convincente (Martini, 1958), l’obbligazione assunta dal lavoratore nella locatio operarum è un’obbligazione a dare (come nella locatio rei) e non a facere (come nella locatio operis). Uno degli argomenti più forti a sostegno di questa interpretazione, oltre a quello già accennato per cui è impossibile definire ex ante la natura specifica delle opere da fare, è basato sull’osservazione che lo stesso concetto di locatio operarum viene usato per la locazione degli schiavi, locatio operarum servi, o più semplicemente locatio servi, nella quale chiaramente il locatore, padrone di uno schiavo, dando in affitto una cosa, lo schiavo appunto, in cambio di una remunerazione, assume l’obbligo di cedere l’uso di un uomo: l’obbligo di dare, dunque, e non di compiere o far compiere un’opera, di facere qualcosa.
Non diversamente deve essere intesa l’obbligazione assunta con la locatio operarum di un uomo libero: si tratta sempre della cessione dell’uso di un uomo. La differenza risiede nel fatto che nel primo caso il locatore dà in affitto l’uso di un altro uomo, mentre nel secondo dà in affitto l’uso di se stesso. Infatti la locatio operarum di un uomo libero si configura anche come locatio sui, locazione di se stesso. Non si tratta comunque di una differenza sostanziale, poiché, se anche è vero che nella locatio servi compaiono tre individui mentre nella locatio sui ne compaiono due, resta il fatto che il terzo individuo, quello che è oggetto della transazione, si presenta non come soggetto giuridico, ma come oggetto: il servo, o meglio il suo uso, è l’oggetto del contratto di locazione. Allo stesso modo l’oggetto della transazione nel contratto di lavoro dell’uomo libero è l’uso del lavoratore stesso. In entrambi i casi dunque agiscono solo due soggetti giuridici, l’oggetto della transazione configurandosi in realtà come una cosa, la cosa che si è assunto l’obbligo di dare.
Ma in cosa consiste questa cosa? Non si tratta evidentemente della proprietà del “capitale umano” incorporato nello schiavo o nell’uomo libero, che legalmente resta parte della dotazione patrimoniale del padrone o dell’uomo libero. Si tratta in realtà della potestas, del potere o autorità che il padrone può esercitare sull’attività dello schiavo e l’uomo libero sulla propria, cioè della capacità di decidere riguardo all’attività del lavoratore oggetto della transazione. Cedere l’uso del lavoratore significa precisamente cedere la prerogativa di determinarne l’attività con un’azione di comando. E ciò resta vero nel caso della locatio servi come in quello della locatio sui. In entrambi i casi il lavoratore locato è tenuto all’obbedienza verso il conduttore. In entrambi i casi il locatore, in quanto proprietario dello schiavo o di se stesso, rinuncia alla prerogativa di esercitare comando sullo schiavo o su se stesso.
Ora è forse più facile rispondere alla domanda “cosa si vende quando si vende lavoro?” Basta riflettere sulla profondità dell’osservazione di Seneca secondo cui “lo schiavo è un salariato perpetuo”, o di quella di Cicerone (1962, pp. 265-6) secondo cui “ignobili e vili sono i guadagni dei salariati, dei quali si paga il lavoro e non l’arte: poiché il salario è il prezzo della loro servitù”. Si vende la libertà. Così come lo schiavo è un salariato perpetuo, il lavoratore salariato è di fatto uno schiavo a tempo definito. [9]-----
Alienazione, feticismo e ideologia del lavoro-merce [10]
“L’economia politica - scrive Marx nei Manoscritti economico-filosofici (1968, p.196) - occulta l’alienazione che è nell’essenza del lavoro per questo: che essa non considera l’immediato rapporto fra l’operaio (il lavoro) e la produzione”. Esiste un’ideologia che domina il pensiero economico moderno sin dai tempi di Adam Smith e da cui non è andato esente nemmeno il pensiero socialista: l’ideologia del lavoro-merce. [11] È basata sull’idea che il lavoratore sia un soggetto dotato di un “capitale umano”, una determinata capacità lavorativa, del quale possa vendere dei flussi in cambio di un reddito che se ne configura come il prezzo. Tale deformazione ideologica viene perpetrata in virtù di una confusione teorica cui si è già accennato, quella del contratto di lavoro col contratto di compravendita di una merce; o meglio, in forza del tentativo di interpretare il contratto di lavoro come una forma complessa e incompleta del contratto d’opera o del contratto di mandato. Come se ne spiega la potenza e la pervasività?
Per capire l’ideologia del lavoro-merce bisogna capire l’alienazione del lavoro. E per capire l’alienazione bisogna partire dal significato giuridico del concetto: alienazione come atto di trasferimento di un diritto a titolo oneroso. Ma solo se si riflette sul fatto che col contratto di lavoro il lavoratore vende, non una merce, bensì la propria libertà, si può capire anche il senso in cui quel termine viene usato nelle scienze sociali e nel linguaggio politico. Alienazione nel lavoro vuol dire perdita della libertà.
E vuol dire innanzitutto che il prodotto del lavoro, l’oggetto dell’attività lavorativa, sorge di fronte al lavoratore come una potenza da lui indipendente. Dunque vuol dire “espropriazione”: non tanto che il prodotto del lavoro diventa un oggetto, quanto che si presenta al lavoratore come un’entità che è a lui estranea, indipendente da lui, e insomma che essa non è cosa sua, e appartiene a un altro. Ciò accade perché, visto che col contratto di lavoro il capitalista acquista la prerogativa del comando sull’attività del lavoratore, questa diventa nel processo lavorativo una manifestazione della sua volontà. L’attività lavorativa, che è azione fisica e mentale del lavoratore, si trasforma in azione economica del datore di lavoro. I prodotti da essa creati appartengono dunque a quest’ultimo, non al lavoratore.
Ma come potrebbe il lavoratore rapportarsi come un estraneo al prodotto della propria attività, se non fosse estraniato da se stesso proprio nell’attività? Il prodotto non è che il risultato dell’azione lavorativa. E se si presenta anche come risultato dell’espropriazione del lavoro, ciò accade solo perché la stessa attività lavorativa è espropriazione, espropriazione in atto. Dal punto di vista del datore di lavoro l’attività lavorativa è una sua proprietà. Dal punto di vista del lavoratore, reciprocamente, è proprietà di un estraneo. Così alienazione vuol dire anche “estraniazione dall’attività lavorativa”. Nel processo produttivo in cui il lavoratore entra in forza di un contratto di lavoro l’attività lavorativa stessa non gli appartiene: in essa egli non svolge alcuna libera energia, non prende alcuna libera decisione. La sua attività non è volontaria, è forzata, è lavoro costrittivo, ed egli è propriamente in sé, è sé stesso, soltanto al di fuori del lavoro. In questo senso alienazione significa che il lavoratore si rapporta alla propria attività come a un’attività non libera, un’attività svolta sotto il comando, la costrizione e il giogo di un altro soggetto. Lavoro salariato vuol dire lavoro alienato. E se non piace Marx, lo si dirà ancora con le parole di Cicerone (1962, p. 266): “sordida è l’occupazione in cui si trovano gli operai, poiché nulla di veramente libero si può trovare in un opificio”.
L’arcano del contratto di lavoro risiede nel fatto che esso induce il lavoratore a sentirsi diverso da ciò che è. Ed è un arcano che sorge da una sorta di contraddizione esistenziale, poiché il lavoratore entra in un contratto di lavoro liberamente, come soggetto autonomo e dotato di completa capacità decisionale. Si verifica l’apparente assurdità di un soggetto che rinuncia liberamente alla propria libertà. Che fare per sostenere il peso di questa vergogna? La via d’uscita più semplice è di abolire, nella coscienza del fatto, uno dei due corni del dilemma. Ed è forse un’inalienabile aspirazione alla dignità umana che induce il lavoratore ad abolire quello più vergognoso: poiché si sente un essere umano, vuole considerarsi libero. Dunque per lui il proprio lavoro deve essere una manifestazione di libertà. Egli ha accettato il contratto liberamente e, per non sentirsi servo di un altro, sia pure solo pro tempore, si convince di aver venduto alla controparte, non un certo numero di ore della propria libertà, della propria vita, ma soltanto una merce. Il soggetto che gli si contrappone, ovviamente, che si sente tutto meno che uno schiavista - e anzi, come datore di lavoro, si sente un benefattore dell’umanità - non ha nulla da ridire su quella convinzione. È così che si instaura il luogo comune, e dunque l’ideologia, del lavoro-merce. Deve essere chiaro però che le radici di questa ideologia affondano nella falsa coscienza dei lavoratori. È sui prodotti di questa falsa coscienza che lavoreranno poi gli economisti.
Nella elaborazione dell’ideologia del lavoro-merce i soggetti economici sono aiutati dal fatto che lo stesso prodotto del lavoro, il risultato della produzione, si presenta come merce. Ebbene se le merci vengono prodotte per mezzo di merci, allora l’attività di produrre merci può apparire naturalmente come una merce essa stessa. È il carattere di merce del prodotto del lavoro che consente quel salto mortale della coscienza mediante cui il lavoratore allontana da sé la consapevolezza della propria alienazione. Esso rende possibile trasformare un’alienazione reale in una estraniazione della coscienza, in un allontanamento della coscienza da sé stessa.
Si è prima accennato all’apparente assurdità di una libera rinuncia alla libertà. In realtà non c’è nulla di strano nell’essere liberi al tavolo delle trattative e soggiogati in fabbrica. L’apparenza di quella stranezza è prodotta dalla difficoltà della coscienza umana di vivere come normale la propria divisione. Cosicché è solo per allontanare da sé l’infelicità di una coscienza divisa che sorge la fuga del lavoratore nella falsa coscienza del lavoro-merce.
È interessante notare che l’estraniazione della coscienza con cui il lavoratore cerca di fronteggiare la propria condizione di alienazione sta alla base di una forma particolare di feticismo, cioè delfeticismo del lavoro considerato come merce. Il rapporto sociale che si costituisce col contratto di lavoro è un rapporto di potere, ma per non essere percepito come tale dal lavoratore, cioè come condizione della perdita della libertà, viene interpretato come un rapporto di scambio di merci. Il lavoratore crede di instaurare un rapporto da pari a pari con il datore di lavoro, almeno giuridicamente, proprio in quanto crede di vendergli solo una merce; ma in tal modo giunge a percepire la relazione sociale che così genera come una relazione tra cose, tra merci, invece che come un rapporto tra uomini.
Accade di peggio però. Poiché la “merce” lavoro che sembra essere fatta oggetto di scambio si configura come l’uso di un flusso di attività nel tempo, essa appare originare da uno stock, un fondo di valori d’uso, cioè di capacità di lavoro usabili produttivamente, che assume il significato di un bene capitale. Da qui origina il concetto di “capitale umano”. Marx usava l’espressione “capacità lavorative” per definire questa grandezza.
Nasce su tale base una particolare forma di feticismo che si potrebbe propriamente definire “feticismo del capitale”. Poiché crede di vendere un flusso di merce-lavoro, e poiché crede che questo scaturisce da un fondo di “capitale umano”, il lavoratore si convince di essere proprietario di tale bene, di un capitale, e anche per questa via arriva a credere che non esiste nessuna differenza sociale sostanziale tra lui e il datore di lavoro: entrambi sono capitalisti; e si scambiano flussi di merci, salario e forza-lavoro, il valore dei quali dipende dall’investimento che entrambi, come proprietari, hanno fatto nel proprio capitale.
Ma se è una finzione giuridica e un inganno ideologico il concetto di “lavoro-merce”, di lavoro come merce, ancor più lo è quello di “capitale umano”, di capacità lavorativa come capitale. Infatti il corpo del lavoratore, “il cervello, i muscoli e i nervi”, non può essere fatto oggetto di proprietà in un sistema sociale che proibisce la schiavitù. Ce lo spiega bene Commons (1981, p. 364):
In questa nuova definizione di lavoro come proprietà e libertà non è ben chiaro che cosa si intenda con ‘lavoro’. Non sta ad indicare, evidentemente, il corpo di chi lavora. In un significato molto impreciso il corpo è proprietà, dal momento che era di questo genere la proprietà di chi possedeva schiavi. Però non è possibile, giuridicamente, trasferire la proprietà del proprio corpo, né esso può essere venduto: quindi non è un bene economico e non ha alcun valore di scambio [...] Ma il lavoratore non può nemmeno vendere l’uso del proprio corpo [...] Quello che egli vende, perciò, è la disponibilità ad usare le sue facoltà in maniera conforme ad uno scopo che gli è stato indicato: vende la sua promessa di obbedire a degli ordini.
Il feticismo del capitale è la radice di ogni ideologia capitalistica del rapporto di lavoro e, oserei dire, dell’essenza umana. Il “capitale umano” è la vera e propria ontologia dell’essere sociale dal punto di vista del capitale. In un sistema sociale in cui le fondamentali relazioni sociali tra persone assumono la forma di relazioni tra stock di capitale, la stessa concezione della libertà personale, la postulazione dell’esistenza di persone dotate di diritti inalienabili di libertà, assume la forma della definizione di un rapporto di proprietà, e precisamente di un rapporto di proprietà in cui l’individuo si trova con se stesso. Da qui nasce il concetto di “proprietà di se stessi” come fondamento della libertà. Ecco come la mette Genovesi (1977, I, pp. 12-3):
Chiamo qui diritto la facoltà morale di servirci liberamente di quel che ci appartiene in proprietà. Questa facoltà, dataci da Dio naturalmente, costituisce i nostri diritti primitivi; per conoscere i quali ragioneremo così. Noi siamo di quella natura forniti, e di quelle forze, che sopra si è veduto [cioè d’ingegno e di corpo]. E benché le une e le altre siano in molte maniere modificabili e variabili, pur nondimeno non si possono da noi separare. Ora tutto quel che appartiene alla mia natura, e che non è da me separabile, è così mio per natura, che non potrebbe essere d’altrui senza che due persone fossero la medesima; dunque è in mia naturale proprietà; e perciò è di mio diritto naturale.
Così sembra che si abbiano dei diritti in quanto si ha una proprietà, dei diritti di libertà in quanto si ha la proprietà di se stessi. Ma la proprietà di se stessi è un’impossibilità giuridica in un sistema in cui gli individui sono dotati di inalienabili diritti di libertà. Infatti, se nessuno può possedere un’altra persona, nessuna persona può essere venduta o acquistata. Perciò nessuno può vendere se stesso o il proprio “capitale umano”. Però una proprietà che è limitata dal divieto di vendita non è una proprietà vera e propria. Al più è un possesso.
Ora, un lavoratore ha il diritto di usare se stesso come vuole e, in un sistema capitalistico, ha il diritto di vendere l’uso di se stesso, appunto assumendo un obbligo all’obbedienza con un contratto di lavoro. Ma non ha il diritto di vendere se stesso. Non c’è nulla nel proprio stato patrimoniale che possa essere considerato propriamente un “capitale” umano. Ma l’ideologia capitalistica del lavoro-merce lo convince proprio del contrario, nello stesso modo in cui lo convince che è dotato di diritti di libertà in quanto è dotato di proprietà di se stesso. Lo convince del fatto che la relazione di comando-subordinazione che instaura con il datore di lavoro è una relazione di scambio di merci, e uno scambio tra individui uguali e ugualmente liberi. Uguali perché sono entrambi capitalisti, lavoratore e datore di lavoro. Liberi perché ciò che è venduto non è un certo numero di ore di libertà, ma una semplice merce.
Tuttavia per la stessa ragione per cui è contraddittorio fondare un diritto inalienabile di libertà sulla proprietà di un bene non alienabile, cioè di un bene che non si ha il diritto di vendere, è contraddittoria anche l’ideologia del lavoro come flusso di merci e delle capacità lavorative come fondo di ricchezza economica. Con il feticismo del capitale il lavoratore si convince di essere un capitalista proprio come il suo datore di lavoro, in quanto è dotato di diritti di libertà proprio come lui. Ma se il concetto di “proprietà di se stessi” è contraddittorio, quello di “capitale umano” è il prodotto di una falsa coscienza.
E l’economia politica, nell’elevare tale prodotto della falsa coscienza a categoria teorica, non fa che il proprio mestiere: dare dignità di scienza alle forme dei luoghi comuni. Per dirlo con le parole di Marx (1964, I, 108): “Tali forme costituiscono appunto le categorie dell’economia borghese. Sono forme di pensiero socialmente valide, quindi oggettive, per i rapporti di produzione di questo modo di produzione sociale storicamente determinato, della produzione di merci”. Ma sia chiaro che si tratta di un’oggettività di “forme di pensiero”, di un’oggettività dei prodotti della coscienza. E tuttavia un’oggettività che produce effetti oggettivi, ad esempio il pagamento di diritti d’autore sulle opere dell’ingegno, o il pagamento di salari differenziati per lavoratori di diversa qualificazione. Il feticismo del capitale pertiene a “esseri umani le cui capacità sono oggettificate” (Ashton e Green, 1996, p.18), o meglio, a esseri umani le cui capacità sono assimilate a un’attività patrimoniale.
[1] Questi problemi sono stati affrontati anche in altri lavori (Screpanti , 1994; 1998; 1999a: 2001), ai quali si rinvia il lettore per approfondimenti.
[2] Marx aveva capito il ruolo svolto dal rapporto di lavoro nel creare le condizioni della produzione di plusvalore. Già nelle sue prime opere economiche aveva compreso che nel contratto di lavoro “l’operaio libero [...] vende se stesso, e pezzo a pezzo” (Marx, 1945, p. 19). Poi nel Capitale (1964, I, pp. 372-3) aveva chiarito che la direzione capitalistica nel processo lavorativo assume la forma di un dispotismo politico e che “l’ordine del capitalista sul luogo di produzione diventa indispensabile come l’ordine del generale sul campo di battaglia”, cosicché “agli operai salariati la connessione dei loro lavori si contrappone [...] come autorità del capitalista, come potenza di una volontà estranea che assoggetta al proprio fine la loro volontà”. L’idea che il contratto di lavoro è una condizione istituzionale fondamentale dello sfruttamento capitalistico è stata sviluppata da Ellerman (1992) in un approccio giusnaturalista e da Screpanti (1994; 1998) in un approccio marxista.
[3] Il principio di equivalenza era presente anche nei classici inglesi e fu assunto perfino da Marx e Engels, che lo chiamavano “legge degli scambi” o “legge del valore”.
[4] Nell’usare tali concetti si farà uno sforzo di astrazione da ogni specifico sistema legale contemporaneo.
[5] Il saggio d’interesse è determinato politicamente e istituzionalmente. Dal punto di vista teorico può essere assunto come fissato ad un livello arbitrario e, volendo, può essere posto uguale a zero. Marx mantiene quest’ipotesi nei primi due volumi del Capitale e nelle prime quattro sezioni del terzo volume. Lo fa per isolare l’analisi dello sfruttamento nel processo produttivo dalle condizioni di circolazione del capitale monetario.
[6] Ma può essere anche deciso in parte al termine del ciclo produttivo, se una sua componente viene fatta dipendere dai risultati conseguiti. In questo caso però il contratto assume caratteristiche che lo assimilano a quello di mezzadria.
[7] Una certa confusione è prodotta dall’uso eccessivamente generico che oggi si fa del modello principale-agente, soprattutto tra gli economisti, un uso che porta a sussumervi pressoché tutte le forme contrattuali adatte alla mobilitazione del lavoro, dal contratto di lavoro al contratto d’opera, da quello di mezzadria a quello di mandato in senso stretto. Per evitare questa confusione il rapporto di mandato (agency) è stato qui definito nel senso che esso ha nel diritto romano. In tale forma contrattuale un mandator (mandante, principal) dà incarico a un procurator (mandatario, agent) di intraprendere autonomamente azioni nell’interesse del mandator stesso. Questo tipo di contratto non comporta l’acquisizione di facoltà di comando da parte del mandator.
[8] Questa tendenza fa il paio con l’inclinazione a ridurre il sistema capitalistico al sistema di mercato. In molte elaborazioni recenti si sostiene che, a causa dell’incertezza, la complessità, il cambiamento tecnico ecc., sia impossibile specificare ex ante le mansioni e le operazioni a cui il lavoratore dovrà piegarsi nel processo lavorativo e che perciò il contratto sarà necessariamente incompleto riguardo alle sue implicazioni tecnologiche. Una tale argomentazione sarebbe valida se il contratto di lavoro fosse riducibile a quello d’opera. Ma le cose non stanno così. Il primo tipo di contratto non ha bisogno di definire la natura dei servizi lavorativi perché non è un contratto di scambio di servizi. Dal punto di vista tecnologico non può essere né completo né incompleto perché è vuoto di implicazioni tecnologiche. Le sue vere implicazioni sono di natura “politica”, in quanto esso istituisce un rapporto di potere, definendone eventualmente i limiti. Può dunque essere incompleto come qualsiasi istituzione negoziale, ad esempio per i suoi effetti su terzi o per la definizione delle norme disciplinari. Ma si tratta di incompletezza relativa ai limiti dell’autorità, non alla natura dei servizi lavorativi. La differenza tra contratto di lavoro e contratto di compravendita è stata colta dagli economisti, e non ancora da tutti, solo in epoca piuttosto recente, e soprattutto per merito di Simon (1951).
[9] Forse è un segno dei tempi, dell’imbarbarimento del capitalismo contemporaneo o, se si preferisce, di una sua impennata di onestà ideologica, il fatto che sta prendendo piede in esso il rapporto di lavoro interinale, una forma di transazione in cui l’uso del lavoratore dipendente può essere ceduto in affitto a terzi con i quali il lavoratore stesso non instaura personalmente un rapporto contrattuale. In questo tipo di rapporto di lavoro viene a cadere uno di veli ideologici che impediscono di afferrare l’intima connessione esistente tra lavoro servile e lavoro dipendente.
[10] La prima parte di questo paragrafo è ispirata alla sezione dei Manoscritti economico-filosofici (Marx, 1968) dedicata al lavoro alienato, ed è anzi scritta per ampie parafrasi di quel testo. Ma l’interpretazione della teoria dell’alienazione qui proposta non è del tutto canonica, così come non lo è quella della teoria del feticismo avanzata nella seconda parte del paragrafo.
[11] Marx stesso restò almeno in parte prigioniero dell’ideologia del lavoro merce, non riuscendo a cogliere la differenza sostanziale che c’è tra un contratto di lavoro e un contratto di compravendita di una merce; e benché avesse sempre avuto ben chiaro in mente che “il salario viene determinato attraverso la lotta ostile fra capitalista e lavoratore” (1968, p. 155), tuttavia ha sempre continuato, sulla scia di Smith e Ricardo, a usare la metafora del mercato per dar conto della determinazione del salario. Marx aveva capito che il “lavoro” non è una merce e che non ha senso parlare di “scambio di lavoro”. Tuttavia avendo posto la “forma-merce” alla base dell’analisi del capitale e il lavoro alla base dell’analisi del processo di valorizzazione, si trovò poi costretto a introdurre il concetto di “forza-lavoro” per dar conto del rapporto di lavoro come basato sulla compravendita di una merce: il lavoratore vende la forza-lavoro e ne riceve in cambio il salario, che è il suo valore di scambio; il capitalista acquista il valore d’uso della forza-lavoro, che consiste nella capacita di creare valore.