1. Nuove frontiere della funzione imprenditoriale e controllo sociale
Per definire o analizzare la figura dell’imprenditore va ricordato che già nel 1700 Cantillon si riferiva all’imprenditore come a colui che prendeva le decisioni, si assumeva i rischi e dirigeva la propria impresa. Nella teoria classica, poi, l’imprenditore altri non era che il capitalista; questa visione è cambiata con i marginalisti i quali definivano l’imprenditore come colui che rischia e coordina mentre il capitalista è chi investe il capitale. È poi Schumpeter a definire l’imprenditore come colui che ha la capacità di intuire, rischiare, prevedere, creare; mentre Knight sostiene che l’imprenditore è colui che sopporta il rischio e affronta l’incertezza.
Per poter comprendere e analizzare il ruolo svolto oggi dall’imprenditore è necessario specificare gli aspetti che maggiormente lo caratterizzano secondo i principi generali dell’approccio economico neoliberista: da un lato vi è la capacità di gestire l’incertezza, da un altro la capacità di svolgere un’attività innovativa e di agire in modo razionale rispetto allo scopo prefissato [1].
Per quanto riguarda il ruolo di innovatore va evidenziato che la diversificazione tra innovazione e attività di “routine” o ripetitiva è un elemento sostanziale per caratterizzare le diverse imprese; l’imprenditore deve saper gestire, coordinare e trasferire sia gli uomini sia i mezzi dai vecchi ai nuovi impieghi. E a questo ruolo si collega il fattore dell’incertezza, in quanto l’imprenditore deve essere in grado di gestire le novità; inoltre è chiaro che è necessaria anche la razionalità economica ed imprenditoriale per raggiungere lo scopo prefissato; se è vero però che lo scopo da raggiungere è legato al profitto, a volte possono intervenire altri fattori quali il prestigio, la soddisfazione personale, lo status, ecc.
L’approccio neoliberista, e non solo, riferisce la funzione imprenditoriale sia ad un fenomeno “interno”, ossia ad una impresa già esistente ed attiva, sia come fenomeno “nuovo” ossia riferita alla nascita di una nuova impresa. [2] L’attività imprenditoriale ha, per questo, tra le sue caratteristiche la dinamicità, la soggettività e l’aspettativa di profittabilità. In sostanza la nascita di nuove imprese può essere considerato, almeno in parte, un atto imprenditoriale (nel significato di Weber, ad esempio, una forte motivazione al successo e il desiderio di indipendenza esaltano le doti richieste ad un imprenditore quali autonomia, capacità di gestire il rischio e l’incertezza, ecc.) [3].
2. Negli anni ’60 il sistema economico e produttivo era governato dalle grandi imprese, a conferma delle teorie di Galbraiht, il quale sosteneva che la principale fonte di progresso per un sistema economico era rappresentato proprio dalle grandi imprese perché avevano una maggiore possibilità di sfruttare le economie di scala e una maggiore capacità di innovare.
Questa tendenza si è però modificata negli anni ’70; infatti i numerosi cambiamenti intervenuti nell’economia del mondo, la crescente importanza dell’innovazione come fattore fondamentale di successo per le imprese e il potenziamento del processo di formazione di nuove imprese hanno riportato ad attualità il concetto dell’imprenditore innovatore di Schumpeter [4].
Negli anni ’80 poi le varie modificazioni strutturali hanno messo in risalto il ruolo prevalente della creatività imprenditoriale soprattutto nelle imprese più piccole.
È in funzione della mutata realtà che si rende sempre più evidente la separazione fra soggetto economico proprietario (imprenditore-proprietario) e soggetto gestore e di controllo (imprenditore-manager-gestore) a cui è riservata la guida dell’impresa e la capacità di realizzare le potenzialità provenienti dai processi innovativi, attuando processi decisori a carattere strategico. Le due specificità si ricompongono poi a momento e funzione unitaria essendo superata ormai la figura classica dell’imprenditore individuale, legata alla fase dello sviluppo delle imprese definita "fordista" o "tradizionale". Da più di quindici anni si è aperta la fase di sviluppo definita del management imprenditoriale subentrata all’era dell’impresa manageriale, fino addirittura a giungere alla fase dell’impresa post-manageriale che proietta nell’era post-fordista un’impresa diffusa socialmente nel sistema territoriale.
3. È la funzione imprenditoriale sul sociale che predomina rispetto al soggetto, di conseguenza la nuova figura imprenditoriale non può che essere di natura plurima e identificata, quasi esclusivamente, nel top-management, anche se solo a volte può anche essere apportatore di capitale di rischio. Si tratta di un nuovo soggetto, meglio di un pool di soggetti, capace di dinamizzare la funzione imprenditoriale in particolare verso l’immagine nel sociale. Quest’ultima proiezione nel sociale della cultura d’impresa viene individuata come una qualsiasi iniziativa imprenditoriale caratterizzata da innovazione, soggettività, gestione del consenso al potere economico e politico d’impresa, derivante dall’innovazione di qualsiasi tipo proiettata nel territorio, nel sociale tutto.
Se la funzione imprenditoriale ha ancora come compito strategico quello di modificare l’equilibrio di mercato, allora le informazioni e la conoscenza diventano risorse intangibili a valenza strategica; pertanto saranno sempre più utilizzate dal decision making per le strategie globali di controllo sociale finalizzato alla competitività di mercato nazionale e a livello internazionale diventano risorsa chiave e fondamentali nella competizione globale. La grande capacità risiede, poi, non solo nel reperire conoscenza e informazioni ma nell’utilizzarle in maniera altamente competitiva e diversa rispetto alla concorrenza, ma, comunque, con l’unico vincolo di trasmettere nel sociale le idee-forza del mercato, che devono diventare idee-guida della società tutta.
Si può, quindi, affermare che la conoscenza è diventata negli ultimi anni un vero e proprio input di straordinaria importanza inserito nel processo produttivo e decisionale, ma nello stesso tempo anche un output che contribuisce in maniera essenziale a svolgere la mobilitazione di risorse per creare redditività e distribuire il bene o il servizio prodotto, ma soprattutto per diffondere la cultura d’impresa allargando gli orizzonti delle nuove frontiere dell’accumulazione flessibile del capitale.
Per realizzare in pieno la funzione imprenditoriale, allora, naturalmente l’impresa muta in continuazione i processi comunicazionali e decisionali, innovandosi e producendo, così, un progresso non solo economico, tecnico-informativo ma anche incidendo significativamente nella soggettualità del lavoro; cioè nei soggetti applicati ad un lavoro che cambia, lavoratori che devono essere capaci di arricchire la qualità della accumulazione di capitale attraverso l’innalzamento delle strutture produttive e dell’intera organizzazione del lavoro in termini di subordinazione completa, voluta o meno, alla modernizzazione e alla flessibilità d’impresa.
I comportamenti produttivi e culturali d’impresa interagenti con l’esterno devono essere capaci di dominare le nuove figure del lavoro e l’incertezza del sociale derivante dai processi innovativi, piegando agli interessi d’impresa tutte le forme che assume o può assumere il conflitto o comunque la competizione fra capitale e lavoro.
La funzione imprenditoriale è, allora, sempre più basata su un processo decisorio-comunicazionale che invade il territorio, è cioè momento decisionale sulle scelte inerenti le formule economico-culturali della società. Decisioni che assumono valenza strategica nel momento in cui per trasformare la realtà sociale si incide sulla potenzialità dei processi di organizzazione dell’antagonismo, mutando completamente la tipologia e le dinamiche del lavoro.
Nel nuovo modello assumono forte rilevanza i processi endogeni di sviluppo che sono specifici di particolari formazioni sociali e territoriali, che facilitano le dinamiche di ristrutturazione di un capitalismo sempre più basato sulla crescita di un’imprenditoria di tipo europeo ma a specifici connotati locali. Quindi piccola e media impresa, affiancata alla grande impresa delocalizzata ed esternalizzata e sviluppo diffuso, caratterizzano un nuovo modo di organizzare la produzione con profonde caratteristiche autonome, ma sempre basate su forme più o meno sofisticate di aumento dello sfruttamento della forza lavoro.
La flessibilità tecnologica consente contemporaneamente sia di incrementare la produttività sia di creare flessibilità nella produzione, producendo così una notevole contrazione del volume della forza lavoro e una diminuzione del tempo di lavoro necessario alla produzione. Il lavoro non è disponibile per tutti, e la flessibilità dei rapporti lavorativi rende lo stesso vivere precario e instabile anche per coloro che ancora godono del posto di lavoro più o meno stabile. Quindi, ogni forma di garanzia dell’epoca fordista viene completamente eliminata dalla trasformazione produttiva del nuovo modello capitalistico cosiddetto post-fordista dell’accumulazione flessibile.
4. È così che si passa dai modelli di capitalismo all’unico modello di capitalismo selvaggio.
È importante ricordare che gli elementi che caratterizzano il ruolo dell’imprenditore hanno dato vita nel tempo a diversi modelli di capitalismo in vari paesi; tra i più importanti si ricordano:
1) il modello “renano- nipponico”,
2) il modello anglosassone,
3) il modello italiano o familiaristico.
Ma ormai è in atto una trasformazione che oltre ad identificare un solo e sempre lo stesso modo di produzione capitalistico con i propri connotati di sfruttamento, identifica allo stesso tempo un accorpamento dei vari modelli verso forme sempre più prive di mediazione.
La trasformazione è sia di tipo quantitativo con una disoccupazione elevatissima nell’Europa ex continentale, sia di tipo qualitativo. Infatti non si può più considerare la fabbrica il luogo della concentrazione del lavoro e della produzione, né lo Stato è la forma di mediazione e regolamento del conflitto sociale. L’intero ciclo produttivo ha scavalcato le mura della fabbrica generalizzandosi alla società intera, lo Stato, adempiendo solo in parte alla funzione di mediazione sociale, si fa portatore nel sociale nelle sue diverse forme della cultura del mercato e degli interessi dell’impresa. Alla produzione viene riconosciuto un ruolo di manipolatrice di oggetti intellettuali, relazionali, affettivi e tecnico-scientifici. Il lavoro è diventato un’insieme di figure produttive inserite in un complesso ambiente sociale.
E la funzione è ancora più dinamica, rendendo realmente attivo il soggetto plurimo imprenditoriale, tanto più l’utilizzo di esperienze e di know-how, di comunicazione, di conoscenza è utilizzato per gestire l’incertezza derivante dall’innovazione, dominando e piegando ai propri obiettivi eventi di cui non si conosce aprioristicamente la distribuzione di probabilità di accadimento e tra questi le potenzialità e le forme che va assumendo il dinamismo sociale, anche con momenti di forte contrapposizione e di conflittualità politico-sindacale. La funzione imprenditoriale non può, quindi, limitarsi a reperire e coordinare le risorse produttive; il suo ruolo, e con essa quello del soggetto-imprenditore, sia esso individuale o collettivo, diventa attivo e si dinamizza nel momento in cui attraverso il recepimento dei flussi conoscitivi, informativi e comunicativi e con l’attuazione dei processi decisori strategici modifica, recependo le innovazioni, l’equilibrio di mercato, ma nel contempo controlla socialmente, influenzandolo, l’intero macro-sistema ambientale in cui l’attività imprenditoriale si esplica.
5. Si sviluppa, comunque, una linea di evoluzione anche delle economie locali che preme sulla distruzione di qualsiasi forma di rigidità per l’impresa, anche di rigidità sociale. Il sistema imprenditoriale si ricentra, perciò, su alcune linee di tendenza che portano il sistema economico nel suo insieme, ed i sistemi di sviluppo locale in particolare, da una partecipazione diffusa ad almeno alcune forme di garanzie sociali universali, al passaggio ad un sistema di accessi selettivi.
Per contraddistinguere i soggetti di comando del localismo si deve guardare al nuovo ruolo assunto anche dagli attori istituzionali di rappresentanza e a quelli finanziari tradizionalmente radicati sul territorio, che diventano soggetti determinanti del dominio locale, come parte attiva del ruolo svolto da uno Stato che ha dismesso il ruolo di regolatore sociale.
Processi ormai finalizzati all’imposizione sociale dell’assunzione dei comportamenti di potere incentrati sui modelli relazionali tra le imprese, focalizzando contestualmente le modalità per una partecipazione qualificata del corpo sociale nei rapporti con le istituzioni, attraverso la scommessa della qualità e della flessibilità produttiva da un lato e la scommessa dell’autorealizzazione, abbattendo qualsiasi logica solidaristica e di tolleranza.-----
2. Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese in Europa
1. Le piccole e medie imprese svolgono all’interno dell’Europa un ruolo fondamentale nell’offerta di prima occupazione in quanto sono molto importanti sia nella formazione sia nell’assorbimento di manodopera meno qualificata e più debole (donne, giovani, ecc.). Le PMI infatti assorbono il 70% circa dell’occupazione comunitaria (di cui 30% per imprese con meno di 10 addetti) e il 70% circa del fatturato dell’UE; inoltre forniscono un valore aggiunto tra il 65 e l’85% (calcolato per i paesi di cui si hanno a disposizione i dati). Per questo motivo la tendenza alla diminuzione sempre più accentuata del numero delle PMI in Europa è un altro tra i fattori che incidono nell’aumento della disoccupazione totale.
2. Va ricordato che non essendovi un criterio univoco di identificazione delle PMI per i paesi europei si è giunti ad accettare i canoni adottati dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI). In particolare vengono considerate Piccole e Medie Imprese le strutture che abbiano un numero di addetti inferiore a 500, una partecipazione al proprio capitale da parte di una grande impresa non superiore a un terzo ed infine un immobilizzo netto di capitale non superiore a 75 milioni di ECU.
Con questi criteri però si può giungere ad analisi errate in quanto i criteri per qualificare le PMI sono forse eccessivi. Ne è prova il fatto che con queste definizioni le PMI costituiscono il 95% circa del totale delle imprese nell’UE con un’occupazione pari al 75% nei servizi e al 60% nell’industria.
Nel 1991 si è cercato di rimediare a questa situazione con il “Documento di lavoro” sugli aiuti di Stato alle Piccole e Medie Industrie (stabilito dalla Comunità): in base a questo documento infatti per avere un aiuto le PMI devono soddisfare a questi criteri:
a) un fatturato non superiore a 20 milioni di ECU
b) un numero di addetti non superiore a 250
c) una partecipazione al proprio capitale non superiore ad un terzo da parte di una impresa di grandi dimensioni.
Ed ancora: per distinguere tra piccole e medie imprese si definisce piccola l’impresa che:
a) ha un fatturato non superiore a 5 milioni di ECU
b) ha meno di 50 addetti
c) è di proprietà di una grande impresa per non più di un terzo.
Va ricordato comunque che le PMI, pur riscontrando problemi nella complessità degli adempimenti amministrativi e giuridici e dalla difficoltà di ottenere finanziamenti, sono presenti in attività meno sensibili alla concorrenza internazionale, nel settore dei servizi e presentano un accentuato sviluppo in tecnologie innovative. Inoltre godono anche di una maggiore flessibilità, offrendo lavoro spesso ad alto contenuto di precarizzazione, grazie alla maggiore occupazione di giovani e donne e ad una migliore organizzazione interna.
Già dalle delibere in materia della Comunità Europea si è data una notevole importanza allo sviluppo delle piccole e medie imprese; il Consiglio dei Ministri della Comunità già sosteneva, infatti, che “Le piccole e medie imprese siano in grado di contribuire notevolmente al processo innovativo e che esse dovrebbero svolgere una funzione importante nell’attuazione delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, contribuendo così a migliorare la competitività dell’industria su basi più vaste; che pertanto si deve riservare una maggiore attenzione alle specifiche esigenze di tali imprese” [5].
Dal momento che le PMI rispetto alle grandi imprese incontrano problemi nella difficoltà di riconversione e modifica dei processi produttivi, difficoltà nell’accesso ai finanziamenti e limitate capacità imprenditoriali e manageriali, la Comunità Europea ha sempre previsto alcune agevolazioni per promuovere lo sviluppo delle PMI.
Tra gli strumenti finanziari più importanti, vi è il Fondo Sociale Europeo, che ha come scopo istituzionale quello di combattere la disoccupazione, promuovere le pari opportunità nel mercato del lavoro, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e rafforzare la formazione dei lavoratori. Vi è anche la Banca Europea per gli Investimenti che, nata nel 1958, è un ente finanziario che concede prestiti a lungo termine per promuovere lo sviluppo delle regioni meno favorite dell’Europa e lo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’ambiente. La BEI concede, ad esempio, prestiti individuali di alto importo finanziario destinati a coprire fino a metà dell’importo dell’investimento, oppure prestiti globali con i quali ottengono il finanziamento le piccole e medie imprese.
Va inoltre ricordato che nel 1984 il Consiglio della Comunità ha stimolato i paesi membri ad adottare delle politiche attive per promuovere l’occupazione femminile nelle PMI. A questo proposito il Belgio nel 1987 ha promulgato una legge atta a favorire la parità di condizioni di occupazione fra i sessi nel settore privato e nel 1990 queste misure sono divenute obbligatorie anche nel settore pubblico. In Francia la legge del 1983 sull’uguaglianza professionale ha obbligato le imprese con più di 50 lavoratori di preparare un rapporto annuale sull’occupazione maschile e femminile in cui sia dichiarato lo stato di fatto in tema di assunzioni, formazione, carriera, lavoro, retribuzione del personale sia maschile sia femminile. In Spagna negli anni 1988-90 è stato approvato un piano di azione per le pari opportunità tra uomo e donna mentre in Germania è entrata in vigore da poco tempo la legge del 1994 sull’uguaglianza di partenza fra uomo e donna; lo scopo è quello di garantire un incremento della presenza femminile in tutti i gradi e in tutte le mansioni.
La legge sulle “Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro” (del 1991) ha raccolto nel nostro Paese la raccomandazione della Comunità del 1984; nel 1992 è stata approvata una nuova legge “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” che ha lo scopo di realizzare le pari opportunità uomo-donna nell’imprenditoria.
3. Studi sulla presenza e la diffusione dell’imprenditorialità in Europa, in particolare per le PMI, evidenziano che il terziario risulta essere il settore nel quale si concentrano la maggior parte degli investimenti. Il tasso di investimento, ottenuto dal rapporto tra gli investimenti fissi lordi ai prezzi correnti e il Valore Aggiunto lordo ai prezzi di mercato, evidenzia che la percentuale del tasso di investimento più alto si trova nella branca dei prodotti energetici seguita dal settore agrario. I dati dell’occupazione mostrano che in media il terziario offre lavoro a circa il 60% dei lavoratori dell’UE; in Grecia e Portogallo invece a fronte di più bassi valori nel terziario vi è un’alta percentuale di lavoratori nel settore agricolo.
4. La Tabella seguente mostra la dimensione delle imprese (i dati si riferiscono al 31 dicembre 1996) ed evidenzia il fatto che i servizi rivestono un ruolo sempre maggiore nel sistema produttivo italiano.
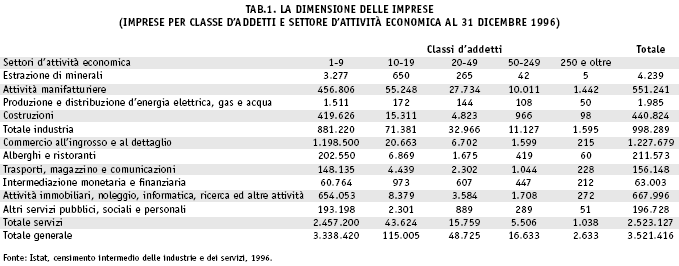
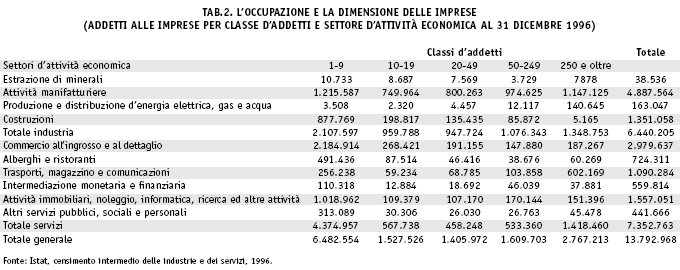
3. Le tendenze della “demografia” d’impresa in Europa e i confronti con l’Italia
Dall’analisi precedente e da un’attenta lettura della realtà odierna, sia sociale sia aziendale, si individuano un nuovo ruolo e una diversa funzione delle dinamiche dello sviluppo che vanno relazionate alle connotazioni del soggetto imprenditoriale. La gestione dell’azienda in particolare in Europa, sempre avvenuta nell’interesse di pochi soggetti economici, sta portando sicuramente a forti processi di ridefinizione.
Il capitalismo europeo, nelle sue diverse componenti, spesso non è stato in grado di realizzare imprese con caratteristiche nuove, dotate di dinamismo, di autonomia, con facile accesso ai finanziamenti e soprattutto tali che non siano guidate da vertici ristretti, ma piuttosto da una varietà di soggetti economici.
Si può parlare di conseguenza di condizioni di omogeneità fra tipologia imprenditoriale e modello di capitalismo di tipo renano-europeo e quelli dell’assetto anglosassone.
I rapporti fra lavoratori e impresa stanno sempre più riguardando solo la responsabilità e la contrattazione aumentando ritmi, produttività e quindi lo sfruttamento dei lavoratori, continuamente utilizzati in funzione di forme diversificate di conflitto orizzontale finalizzato alle motivazioni, aspirazioni e compatibilità con gli obiettivi aziendali.
Tra le condizioni di omogeneità che comunque favoriscono la diffusione di un nuovo modello europeo sempre più vicino a quello statunitense-anglosassone va allora evidenziato il forzato incremento di produttività del lavoro dovuto al ruolo delle nuove tecnologie non più incorporate in grandi impianti (diffusione orizzontale), la crisi provocata dei mercati di prodotti standardizzati nonché l’abbassamento delle barriere all’entrata di nuove imprese.
L’impresa europea ormai si diffonde socialmente nel tessuto territoriale attraverso modalità innovative del ciclo produttivo e dell’accumulazione, quindi dello sfruttamento del lavoro, realizzando risultati economici e sociali positivi, come capacità di governo-controllo delle risorse e di tutte le variabili interne ed esterne.
2. Di seguito si riportano alcuni dati demografici dell’assetto d’impresa in Europa [6].
Nell’UE, sono presenti circa 17 milioni di imprese industriali e servizi [7], con circa 102 milioni d’addetti. I cinque più grandi paesi in termini di popolazione e di prodotto nazionale lordo [8] riuniscono intorno a loro l’80%, sia delle imprese sia degli addetti; l’Italia contribuisce con circa 3,5 milioni d’imprese, che occupano poco meno di 14 milioni d’addetti [9]. Il nostro Paese ha circa il 21% delle imprese e il 13% degli addetti nell’area comunitaria, con una dimensione aziendale nettamente più ridotta di quella prevalente dell’UE. In Italia è presente circa il 27% delle imprese industriali, il 18% di quelle delle costruzioni e il 21% delle imprese dei servizi dell’Unione; questi tre macrosettori, in termini d’addetti, costituiscono rispettivamente circa il 15%, il 13% e il 12% del totale dell’occupazione dell’area UE. La dimensione media delle imprese italiane è pari a circa quattro addetti e si confronta con valori pari a 11 per l’Olanda e l’Austria, 10 per il Lussemburgo e l’Irlanda, 9 per la Germania e la Svezia, 7 per la Francia, 6 per la Gran Bretagna, circa 5 per Spagna e Portogallo (la dimensione media per l’UE è di 6 addetti per impresa).
La dimensione media [10]delle imprese è più bassa nei paesi dell’Europa meridionale; per esempio la Grecia evidenzia un valore inferiore a quello italiano, con poco più di due addetti per impresa. Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia e Regno Unito presentano una dimensione media delle imprese prossima alla media EUR-15, anche se le rispettive strutture economiche sono significativamente diverse tra loro.
Il sottodimensionamento relativo delle imprese industriali e dei servizi in Italia dipendono solo in parte dalla diversità tra le strutture produttive, essendo sistematicamente verificato in tutti i principali comparti d’attività economica. Ad esempio, la dimensione media dell’industria italiana pari a 9 addetti e quella dei servizi a quasi 3 addetti, contro rispettivamente, circa 16 e 5 addetti nella media dell’Unione Europea. Anche ad un livello settoriale più dettagliato, si verifica un netto sottodimensionamento delle imprese italiane nei confronti dell’area UE: in particolare, nelle imprese del comparto del legno e della carta, nella categoria delle altre industrie manifatturiere, nel commercio all’ingrosso e nei servizi alle imprese, la dimensione media delle imprese italiane è pari alla metà di quella UE. D’altra parte, la dimensione media delle imprese italiane è superiore a quella comunitaria nel caso dei prodotti energetici, nella fabbricazione d’autoveicoli, nella produzione e distribuzione d’energia elettrica, gas e acqua, nei trasporti e nei servizi postali e telecomunicazioni.
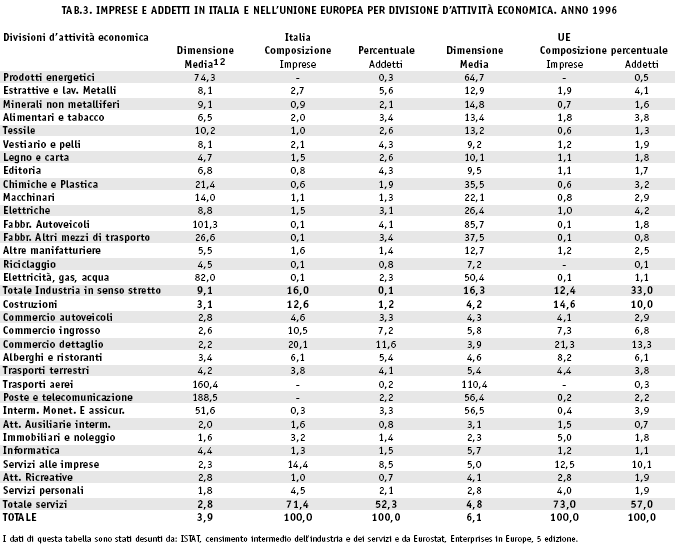
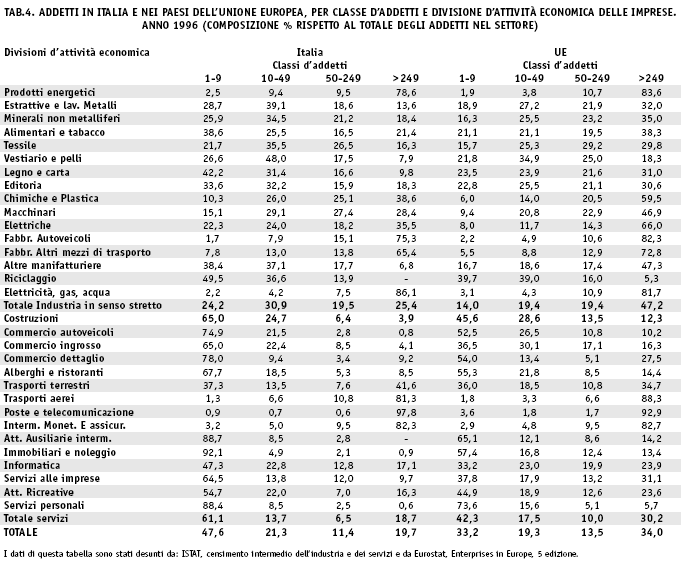
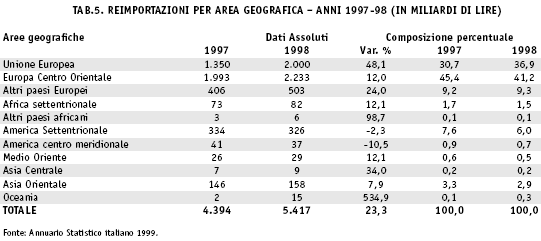
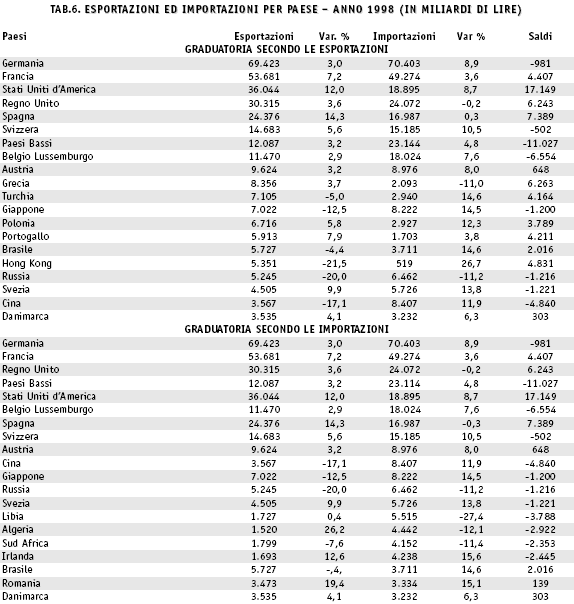
Il dato relativo alla concentrazione sintetizza le proporzioni esistenti, in ciascun settore, tra piccole e grandi imprese in termini d’assorbimento occupazionale. Analizzando la distribuzione degli addetti per classe dimensionale delle imprese, si registra una netta prevalenza occupazionale delle piccole imprese, ossia quelle con meno di 50 addetti. -----
3. In pratica, a livello di macrosettore, l’Italia presenta uno scarso peso dell’occupazione delle grandi imprese del settore industriale e, per contro, uno estremamente elevato delle piccolissime imprese dei servizi. In questo contesto, è rilevante il posizionamento delle imprese italiane all’interno dell’area UE, il quale può essere valutato attraverso l’analisi dei dati di produzione e di commercio estero, sulla base di un insieme d’indicatori strutturali e di redditività desunti dai bilanci delle imprese [11].
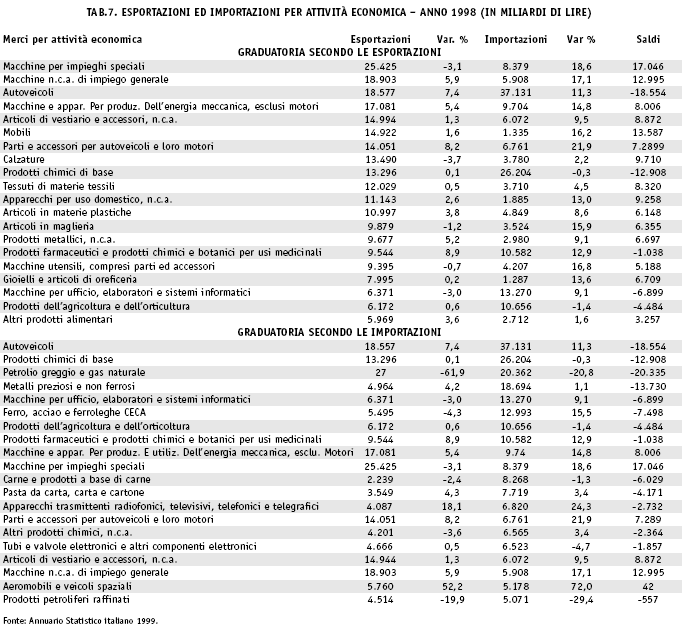
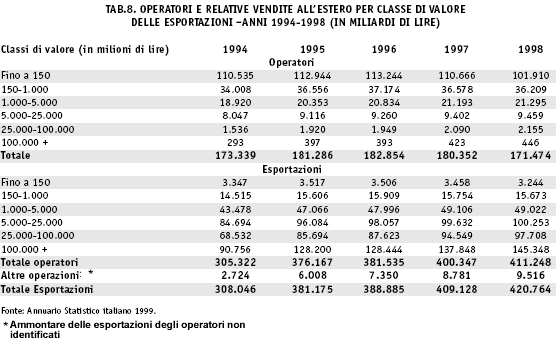
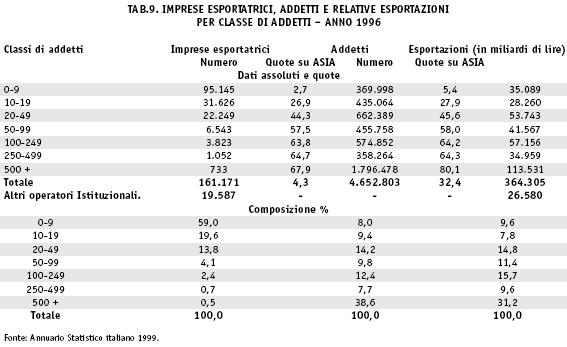
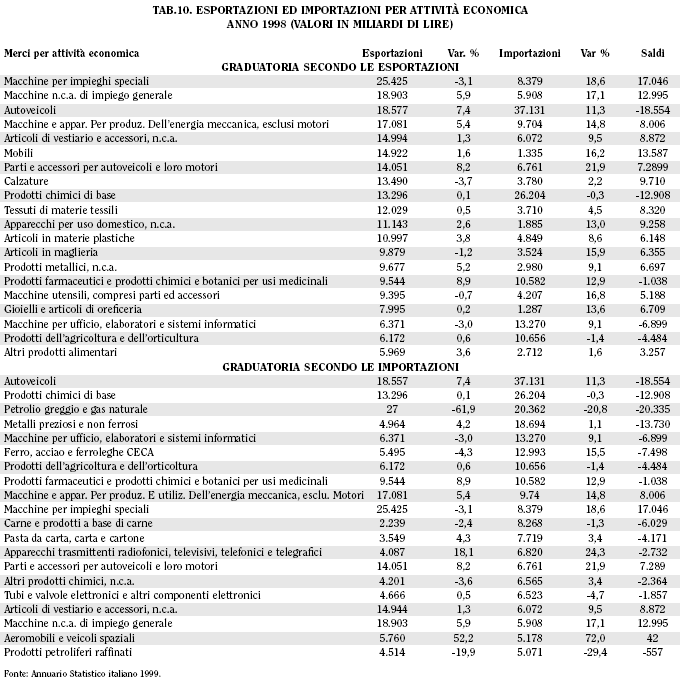
L’orientamento verso i mercati esteri del sistema della piccola e media impresa italiana rappresenta uno degli indicatori ai fini della valutazione del grado di integrazione nei processi innescati dalla competizione globale dell’economia.
I principali mercati di sbocco delle esportazioni nel 1998, sono stati la Germania, con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente, la Francia (+7,2%) e gli Stati Uniti d’America (+12%). Le principali attività economiche, significativi saldi attivi si riscontrano per le macchine e gli apparecchi meccanici (+56.016 miliardi), i prodotti delle industrie tessili e dell’abbigliamento (+26.570 miliardi) e gli altri prodotti dell’industria manifatturiera (+21.406 miliardi). I principali raggruppamenti di prodotti esportati sono stati le macchine per impieghi speciali, le macchine di impiego generale (+5.9%) e gli autoveicoli (+7,4%). I principali mercati di sbocco per le nostre esportazioni sono costituiti dall’Unione Europea (il 56,4%), dall’America Settentrionale (il 9,4%) e dall’Europa centro-orientale (7,9%) mentre dal lato delle esportazioni, le aree di maggior interesse sono l’Unione Europea (61,6%), l’Asia orientale (7,8%) e l’Europa centro-orientale (6,9%).
I flussi in regime temporaneo danno conto di alcune importanti forme di scambio che contraddistinguono il sistema della sub-fornitura internazionale e forniscono indicazioni sui processi di delocalizzazione all’estero delle imprese. Le reimportazioni rappresentano, infatti, nel 1998, l’1,5% del valore complessivo delle importazioni, con un incremento di oltre il 23% rispetto all’anno precedente. Le principali aree geografiche di provenienza dei flussi sono l’Europa centro orientale (41,2% sul totale) e l’unione Europea (36,9%).
Oltre il 40% degli operatori esporta merci verso un unico mercato e meno del 15% opera su oltre dieci mercati. Risulta evidente la presenza diffusa degli operatori nelle principali aree di scambio internazionale.
La quota delle imprese esportatrici sul totale delle imprese attive cresce significativamente all’aumentare della dimensione di impresa, (espressa in termini di addetti).
4. Distretti industriali europei e Italia multinazionale
1. Un cenno meritano a questo punto anche i cosiddetti distretti industriali europei. A questo proposito si distinguono, ai fini di una politica economica, zone residenziali e zone produttive; queste ultime sono proposte come una sintesi delle interrelazioni tra struttura produttiva e territoriale in cui dall’analisi ed osservazione della realtà si evidenziano quelle di specializzazioni produttive che danno origine ai distretti anche a carattere europeo internazionale.
Anche per la maggior parte degli studi della fine anni ’80 e inizio ’90 l’obiettivo fondamentale è stato quello di individuare le dinamiche localizzative del modello di sviluppo dei singoli paesi; e spesso prevale una forzata interpretazione che consiste nel porre i presupposti per un analisi economica dello sviluppo regionale al fine del riconoscimento dei Distretti Industriali Marschalliani (DIM) sul territorio nazionale [12] anche se poi la dimensione del distretto, in funzione delle esternalizzazioni e dell’intensificarsi dei processi di delocalizzazione, assume sempre più spesso caratteri internazionali.
2. È in tale chiave che va letta la grande importanza che viene attribuita al nuovo concetto di distretto industriale internazionale e in particolare a centralità europea, il quale ha una forte specificità, una propria dimensione socio-economico e territoriale, definita in funzione delle relazioni di coercizione comportamentale complessiva che si instaurano tra imprese e comunità locale del paese (per esempio le relazioni fra Italia ed Europa centro-orientale) dove più si effettuano IDE, e una specifica forzata capacità autocontenitiva in relazione a domanda e offerta di lavoro realizzata tramite marginalizzazione, precarizzazione ed espulsione dei soggetti economici e produttivi non compatibili. Sempre secondo tale interpretazione socio-economica vanno analizzate le trasformazioni tecnologico-produttive che caratterizzano alcune realtà territoriali, determinando la crescita d’importanza di sistemi reticolari, in ambito europeo e anche internazionale, i quali si configurano come reti territoriali che si formano intorno a grandi imprese con forti connotazioni locali e reti risultanti dalla deverticalizzazione congiunta di grandi imprese produttive in ambiti locali e con forti connotati a specializzazione produttiva locale [13].
Se si analizza il concetto di internazionalizzazione riferito ai distretti industriali europei va ricordato che "una prima forme di internazionalizzazione dei distretti industriali è quella che vede il decentramento all’estero di alcune fasi intermedie del distretto, malgrado fasi terminali per le singole imprese. In questo caso si attua un decentramento internazionale di una fase produttiva, attraverso la scomparsa dell’offerta locale, e delle relative imprese, di quei prodotti di fase che sono stati decentrati. Il bene intermedio prodotto all’estero può ritornare alla produzione del distretto, andando a ricomporre l’intero processo produttivo, od essere destinato ad una distribuzione commerciale, interna o esterna al distretto o, addirittura, essere collocato sul mercato esterno dei prodotti di fase [14]".
3. In Italia è la forte presenza di piccole e medie imprese con una specializzazione flessibile a rendere il mercato in grado di adattarsi alle mutevoli oscillazioni della domanda. I bassi costi dell’organizzazione e relativamente quelli del lavoro, consentono alle piccole imprese di immettere sul mercato sempre nuovi prodotti anche se deve essere ridotto anche il “costo degli errori e dell’uscita dal mercato. Ciò è reso possibile dalla protezione offerta dalla famiglia, dato che il reddito familiare è per molti piccoli imprenditori l’unità entro cui si compensano i guadagni e le perdite; dall’alta propensione al risparmio, a cui le piccole imprese possono attingere anziché ricorrere al mercato dei capitali; e dall’assenza di investimento in capitale umano, visto che le competenze (e talvolta le attrezzature) vengono per lo più acquisite in una precedente posizione di lavoro dipendente, a partire dalla quale si prova a <mettersi in proprio> [15]”. Le medie imprese invece si richiamano di più alla tipologia di quelle tedesche o a quelle francesi.
In Italia, si è detto, sono presenti anche un vasto numero di piccole e medie imprese che soprattutto negli ultimi anni stanno sviluppando sempre di più la dimensione e nella dimensione del distretto trasnazionale con centralità europea. Inoltre in Italia i tassi di “natalità di nuove imprese” sono (in apparenza) alti in quasi tutti i settori, in quanto presentano valori che raggiungono spesso il 10%; anche i tassi di mortalità, però, sono elevati e solo di poco inferiori a quelli di natalità; questo dimostra che vi è un alto processo di turnover che risulta però essere limitato solo alle piccole imprese. Infatti a fronte di una facile nascita di nuove piccole imprese vi è la scarsa possibilità per queste aziende di sopravvivere oltre il terzo anno.
Nel nostro Paese si viene a realizzare in sostanza ad una forma di imprenditoria di élite tipica delle grandi aziende, un’imprenditoria della piccola e media impresa ed infine all’imprenditoria assistita. Questa situazione fa risaltare lo storico problema delle “tre italie imprenditoriali”, in quanto gli imprenditori d’élite sono concentrati nell’Italia settentrionale, al centro troviamo un tipo di imprenditorialità diffusa mentre al sud si trova il cosiddetto “imprenditore assistito” legato al sistema politico.
Va segnalato che il Censis nel 1997 ha calcolato in Italia oltre 200 distretti industriali con più di 120 miliardi di fatturato ed oltre 2.200.000 addetti che rappresentano il 42% dell’intera occupazione manifatturiera italiana, distretti che ormai delocalizzano la produzione in particolare nel centro-est europeo.
I distretti industriali italiani proiettati in Europa, e quindi a carattere internazionale, operano per la maggior parte nel campo del cosiddetto "made in Italy" che interessa e riguarda settori che agiscono nelle aree moda, meccanica collegata, arredo-casa, alimentazione mediterranea e tempo libero [16].
Vi sono distretti conosciuti, che vanno assumendo anche carattere internazionale, come ad esempio Prato, Como, Biella ed altri che pur essendo molto piccoli hanno creato una loro nicchia particolare di mercato e che sono ormai conosciuti in tutto il mondo (ad esempio il distretto di Bergamo per i bottoni, o quello a Lecco delle forbici). Ed ancora: è importante il distretto delle macchine per imballaggio a Bologna che conta più di 200 aziende con oltre 13.000 addetti e più di 3.000 miliardi di fatturato; il distretto di Mantova (Castel Goffredo) con la sua produzione di calze femminili raccoglie circa 300 aziende ed occupa tra i 7.000 e gli 8.000 addetti [17]. Il Sud si distingue per il distretto di Bari e Matera con più di 250 aziende e più di 6.000 addetti [18].
Va ricordato che i distretti industriali hanno creato occupazione in questi ultimi anni molto di più della grande industria che invece ha registrato una diminuzione generale degli occupati.
Le varie rilevazioni ISTAT evidenziano che il Made in Italy, in particolare quello realizzato nei distretti internazionali, è formato soprattutto da piccole e medie imprese; più del 30% dell’occupazione del Made in Italy è raggruppato in aziende con meno di 10 lavoratori; le aziende con lavoratori da 10 a 49 raccolgono quasi il 35% dell’occupazione made in Italy e le aziende con addetti da 50 a 199 concentrano il 18% degli addetti. In totale circa l’85% dei lavoratori del made in Italy è raggruppato nelle piccole e medie imprese [19].
4. In base al riferimento che fa l’ISTAT dei 236 gruppi merceologici che delimitano il commercio estero e considerato il 1995 come anno base, vengono considerati come facenti parte del Made in Italy, che soprattutto si sviluppa nei nostri distretti a carattere nazionale, i gruppi merceologici appartenenti ali settori sopra citati (moda, meccanica collegata, arredo-casa, alimentazione mediterranea e tempo libero) e che nel 1995 abbiano presentato esportazioni più alte di 1000 miliardi di lire.
In questo modo l’ISTAT ha indicato 51 gruppi merceologici facenti parte del "Made in Italy" (di cui 9 gruppi merceologici alimentari, 20 gruppi merceologici di "Moda", 5 di "arredo-casa", 15 di meccanica tradizionale, 2 merceologici residuali.
La Tab.11 mostra come il "Made in Italy" abbia influenzato positivamente il commercio estero italiano; nel 1997 infatti a fronte di un saldo negativo per l’import-export del settore materie prime ed energia ed un saldo ancora negativo per altri settori (mezzi di trasporto, informatica, ecc.) il settore del Made in Italy ha presentato un saldo molto positivo in grado di garantire alla bilancia commerciale italiana un saldo finale positivo (cfr. Tab.11) [20].

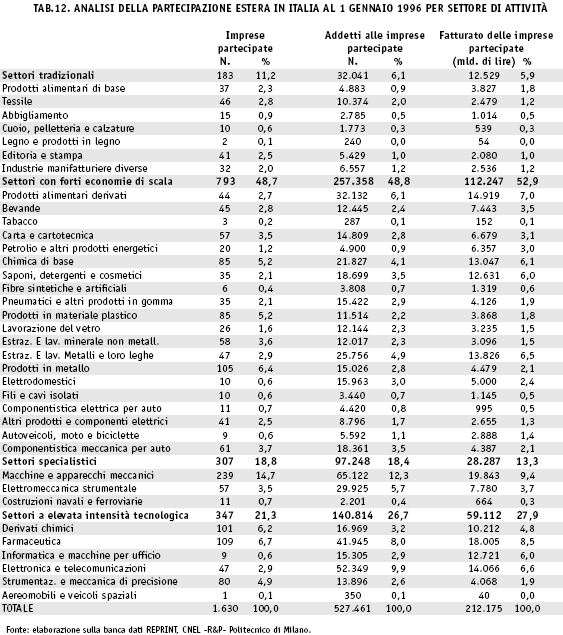
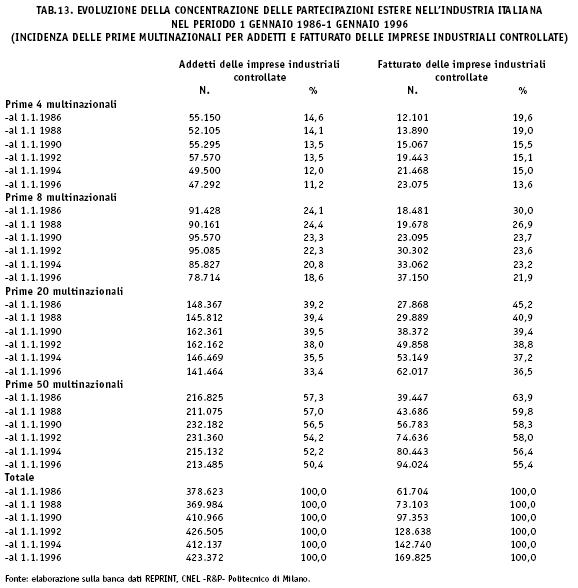
Ovviamente vi sono anche nel Made in Italy prodotti che vanno molto più degli altri; ad esempio nel 1996 nel nostro Paese si è avuto un alto attivo commerciale mondiale in più di 20 prodotti quali la lana, calze, maglioni, pelli conciate, calzature, mobili, cucine, macchine per lavorare il legno ecc. [21]
5. È chiaro comunque che il processo di competizione globale nell’internazionalizzazione produttiva che interessa ormai gran parte delle imprese nei sistemi di capitalismo occidentale rende necessario anche per le piccole e medie imprese italiane un adeguamento; in questo senso gli attuali distretti tenderanno a trasformarsi da "reti locali" a "reti che varcano i confini nazionali" con un sistema sempre più efficiente di flessibilità organizzata tendente a ridurre i costi per poter competere con le grandi imprese multinazionali per poter essere in grado di scegliere dove e cosa produrre in base al costo delle materie prime ecc., ma soprattutto continuando a delocalizzare in funzione dei costi del lavoro, della deregolamentazione, flessibilità e precarizzazione del mercato del lavoro.
Analizzando i settori dell’investimento estero si rileva una forte predominanza dei settori con forti economie di scala che raggiungono il 48,7% del totale (con 793 imprese partecipate); seguono i settori ad alta intensità tecnologica con il 21,3% (347 imprese), i settori specialistici con il 18,8% (307 imprese) ed infine i settori tradizionali con l’11,2% (183 imprese). (Cfr. Tab.12)
La tabella 13 che nel nostro Paese la presenza estera si caratterizza per un insieme molto solido di gruppi multinazionali e comunque i primi quattro gruppi multinazionali che investono in Italia sono l’11,2% del totale per addetti e il 13,6% per fatturato, come meglio si può vedere da un’attenta lettura delle Tabb. successive.
-----
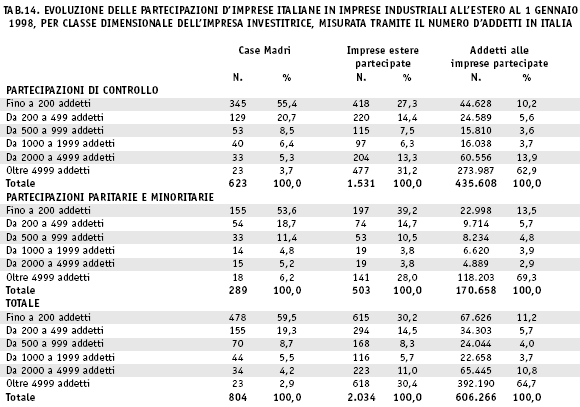
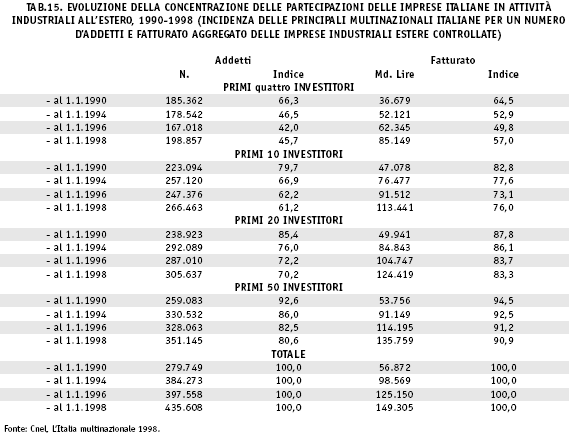
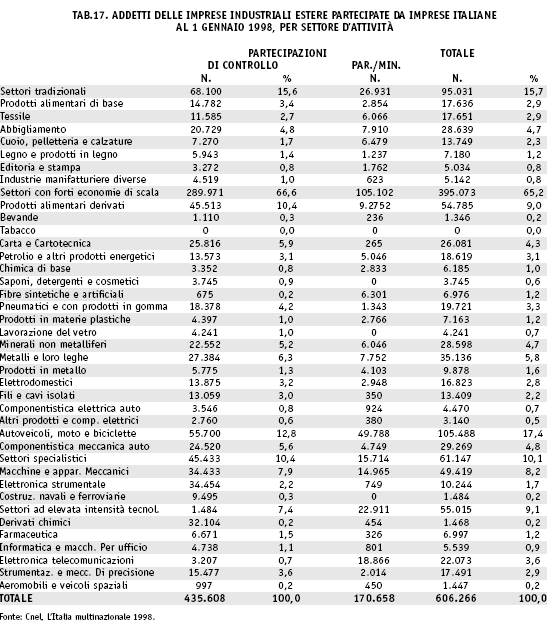
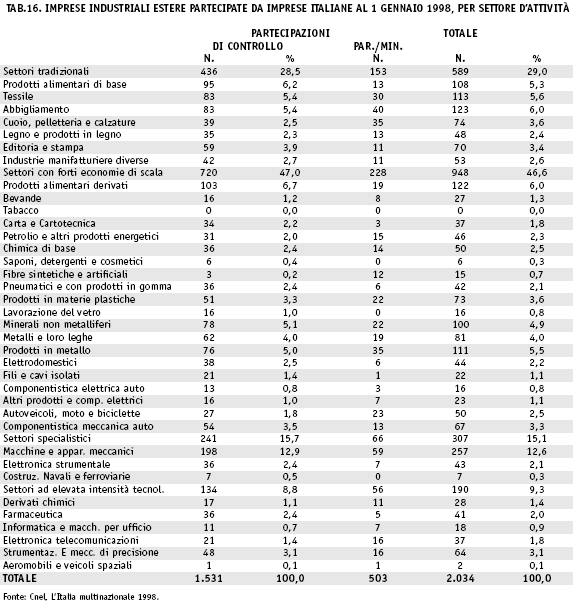
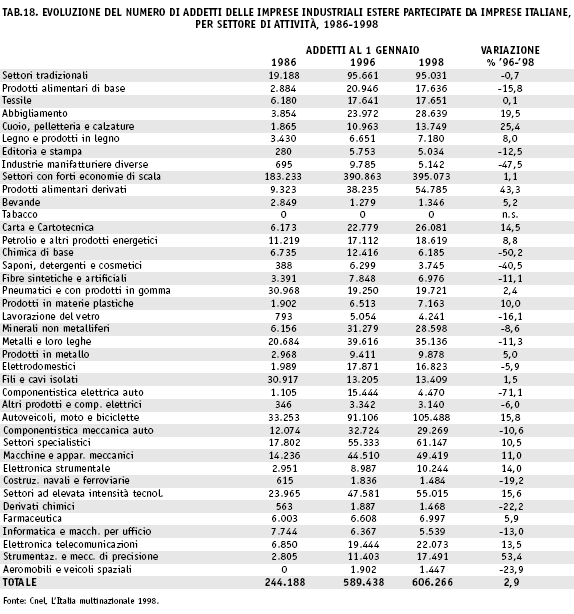
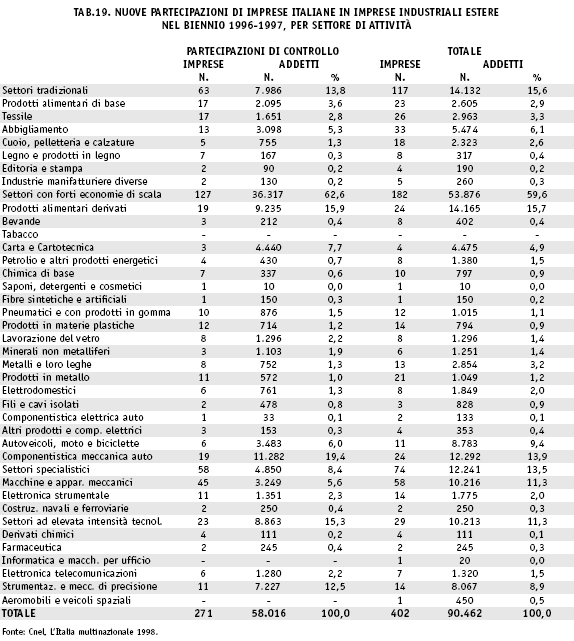
[1] Cfr. Mussati G. (a cura di), “Alle origini dell’imprenditorialità. Nascita di nuove imprese: analisi teorica e verifiche empiriche, ETASLIBRI, Milano, 1990.
[2] Cfr. Vasapollo L., “Dall’entrepreneur all’imprenditore plurimo. Sulla teoria economica della funzione imprenditoriale”,CEDAM, Padova, 1996.
[3] Va però sottolineato che la nascita di nuove imprese può incontrare ostacoli per le cosiddette “barriere di entrata” rappresentate, ad esempio, dai forti investimenti necessari per gli impianti, l’accesso a tecnologie complesse, ecc. Anche le istituzioni possono favorire o ostacolare la natalità imprenditoriale, in quanto la disponibilità di una accessibile rete finanziaria, la possibilità di formare dei consorzi o associazioni, gli incentivi, ecc. possono facilitare la nascita di nuove imprese ma al contempo, come avviene puntualmente in Italia, possono anche creare la cosiddetta figura “dell’imprenditorialità assistita” che ha caratterizzato per molto tempo interi settori e vaste aree del nostro Paese.
[4] Soprattutto nella “Teoria dello sviluppo economico” infatti, Schumpeter sosteneva che l’innovazione è il frutto di ogni individuo che crea una nuova impresa e che l’azione di imprese di minori dimensioni sono il risultato dell’innovazione.
[5] CEE, Filosofia comunitaria e prospettive, Bruxelles, 1995.
[6] Vi sono diversi tipi di indicatori che definiscono la “demografia” delle imprese come ad esempio il tasso di natalità, quello di mortalità, il tasso di sviluppo. Il tasso di natalità è dato dal rapporto tra le nuove imprese e lo stock di imprese esistenti, mentre il tasso di mortalità è dato dal rapporto tra il numero delle imprese morte e il totale delle imprese; il tasso di sviluppo delle imprese invece, è dato dalla differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità; vi sono poi gli indici di densità, di dimensione e la struttura sociale. L’indice di densità d’impresa è dato dal rapporto tra il numero di imprese e i chilometri quadrati dell’area geografica considerata; l’indice di dimensione è dato dal rapporto tra il numero di addetti e il numero delle imprese sempre riferiti ad una determinata area geografica o settore; infine la struttura sociale è data dal rapporto tra il numero delle imprese per area geografica e settore e la popolazione residente. Per questi indicatori cfr. Salvatori F. (a cura di), “Impresa e territorio, contributi ad una geografia dell’impresa italiana”; PATRON, Bologna, 1993.
Con il coefficiente di localizzazione imprenditoriale (Per il coefficiente di localizzazione cfr. Vasapollo L., “Sulla localizzazione della funzione imprenditoriale”, in Temi di attualità n.2 del Dipartimento di Contabilità Nazionale ed Analisi dei Processi Sociali, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma, 1996.) si arriva poi alla misurazione, in un determinato tempo t, delle intensità della dotazione imprenditoriale di una determinata unità di territorio T. Attraverso questo coefficiente si può arrivare alla costruzione di “mappe” delle ripartizioni territoriali dell’Italia dotate più o meno di imprenditorialità. In questo modo è possibile distinguere i diversi bacini o aree in grado di generare o diffondere imprenditorialità.
[7] Dati omogenei relativi al 1998.
[8] Ci si riferisce a Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito.
[9] Dati omogenei relativi al 1996.
[10] Dimensione media = (numero di addetti / numero di imprese).
[11] I valori di tali indicatori, riportati nelle tabelle seguenti, sono espressi in percentuale.
[12] Il distretto industriale è identificato da Marshall come “interazioni interne ad un sistema di imprese di modeste dimensioni, spazialmente concentrate operanti in fasi diverse del processo produttivo con una certa popolazione, operaia e non, su un territorio di insediamento, industriale e residenziale relativamente ristretto”.
[13] Cfr. Vasapollo L., " Analisi statistico-economica dei mutamenti strutturali e localizzativi dello sviluppo del sistema socio-economico italiano, in Proteo n.0.
[14] Caroli G.M., Fratocchi L. (a cura di), "Nuove tendenze nuove strategie...", op. cit., pag.192-193.
[15] M. Regini, “Modelli di capitalismo...”, op. cit., pag.42.
[16] Non si prende in questo caso in considerazione il settore del turismo limitandosi ad analizzare il settore manifatturiero.
[17] I dati si riferiscono al 1998.
[18] Cfr.A. Quadro Curzio, M.Fortis "Il made in Italy oltre il 2000",il Mulino, Bologna,2000.
[19] Cfr.A. Quadro Curzio, M.Fortis "Il made in Italy ...", op. cit.
[20] Cfr.A. Quadro Curzio, M.Fortis "Il made in Italy ...", op. cit.
[21] "Tale aggregato di beni commerciato dall’Italia rappresenta, in valore assoluto, la settima principale voce di esportazione dei paesi OCSE immediatamente dopo colossi quali la meccanica elettrica ed elettronica di Giappone e stati Uniti e la meccanica non elettrica della Germania. Ma, a livello di export pro-capite, il dato dell’Italia in questo aggregato di beni costituisce addirittura la più importante categoria di merci in assoluto tra i paesi OCSE con circa 1.179 dollari di esportazioni per abitante nel 1992...". Cfr.A. Quadro Curzio, M. Fortis "Il made in Italy...", op. cit., pag.35.